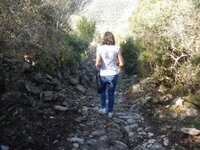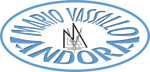TEMPI DA LUVI - LUCIANO DABROI
"TEMPI DA LUVI" DI LUCIANO DABROI
(Per gentile concessione Liliana Petrucco e Anna Maria Dabroi)
y
Tempi da Luvi

Rollo: anni 30-40
Luciano Dabroi
y
Presentazione: Corrado Camandone.
Cartoline e fotografie: collezione Vezzaro Marino.
Disegni: Adriano Lunghi.
Commento: Angela Biedermann.
Pubblicato con il contributo del Comune di Andora.

y
TEMPI DA LUVI
Rollo: anni 30-40
Memorie di Luciano Dabroi
E’ un documento prezioso da conservare e divulgare. E’ vera storia, secondo il nuovo concetto che propone la documentazione e la conoscenza non solo dei grandi avvenimenti, legati a pochi personaggi della politica, dell’arte, della scienza e ad avvenimenti di risonanza mondiale, ma anche di ciò che riguarda la grande maggioranza della gente, la loro situazione concreta, la qualità della loro vita.
Tempi da luvi è la precisa fotografia del livello di civiltà, di cultura, usi, costumi e linguaggi di forse tutta la Liguria, negli anni a cui si riferisce.
E’ una raccolta, una specie di esposizione di quadretti vivi, tracciati con mano esperta, linguaggio chiaro, scorrevole, creatore di immagini. Il contenuto è attraente e divertente. Le avventure del protagonista, che con generosa indulgenza possiamo definire vivace, spiccano sullo sfondo che documenta con precisione il livello di una civiltà. Fame, freddo, fatica, continuo contatto con la natura, avara fonte di vita e unico divertimento, metodi educativi, pericoli di ogni genere, rassegnazione. Tutto questo si scopre con chiarezza essendo quasi spettatori delle avventure di questo ragazzo pieno di fantasia, di iniziative, di coraggio, di incoscienza, di vivacità incontrollabile, vivo per miracolo in mezzo a tanti esplosivi.
Certamente il protagonista delle scappatelle, una specie di Pinocchio nostrano, non può essere preso a modello dai nostri ragazzi, ma la conoscenza del mondo in cui si muove è di estremo interesse.
Senza storia non c’è cultura e la storia è conoscenza del passato, per capire il presente e progettare il futuro. I frutti del progresso di cui godiamo non sono realtà naturali come le nuvole in cielo o le onde del mare, ma il risultato di impegno umano, compito necessario di tutte le generazioni, secondo l’intuizione del filosofo Ortega, esposta nella sua magistrale opera “La ribellione delle masse”.
L’opera di Luciano Dabroi, nata di getto sotto la pressione dei vivi ricordi, ci costringe a prendere coscienza di tutto ciò che oggi abbiamo più di ieri, e nello stesso tempo ci lascia capire come sia invincibile la nostalgia per una vita più semplice e più vicina alla natura.
E’ un granello di sale per la vita insipida dei troppi che conoscono il prezzo di tutte le cose e il valore di nessuna.
Andora, 25 luglio 2001
Corrado Camandone
y
A PINUCCIA E GIUMIN
Per i quali non sono certamente stato un figlio esemplare.
Almeno da bambino!
y
INDICE
Le prime botte
Gialì
Ninin
L’aereo francese
Anna e la cera
Le bisce
La civiltà del risparmio
Natale
I canarini del prete
Il figlio della lupa
Il lume ad olio
La nave delle arance
Luènsu
Babòlu
Le mine
U Bainòttu
Gli uliveti
Gigéttu
L’olio di fegato di merluzzo
Carmelina
L’incendio
U cundiùn
Cesare de Carmelìn
Baciccia
I salvagente e le stoffe
La bomba a mano
E cunfine
Fiuìna e Battistin Fiuìna
I diti
Il barbiere
Gli scarponi
Petalìn
Il ciliegio del Noru
U Tibì
Il mulino del fico
Il sale
U Gin de Testùn
Il fucile 91
Bacicìn da Lasagna
La vita a Rollo
Lo spezzone incendiario
Casa
Il sergente Bruno
Teejola
La caccia col vischio
La radio del prete
Sprazzi
La polveriera
La fine del sogno
y
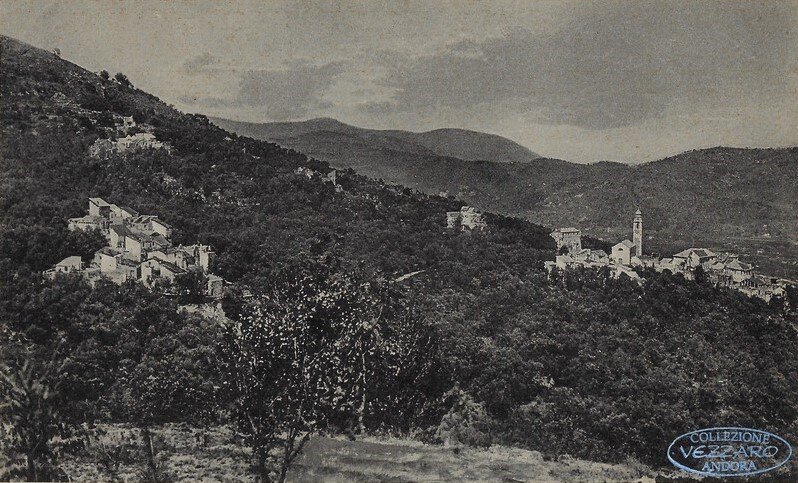
Panorama della frazione di Rollo nel 1935.
Si distinguono le sette borgate della frazione:
- a sinistra “Bande de Là”
- in alto “ Ca’ Survòne” e “ Ca’ Bernei”
- a scendere “Ca’ Stalla”
- “Cae Peai”
- la canonica
- “Cae Taiaferi”
- la chiesa
- “Cae Suttàe”
La piccola macchia chiara in alto a sinistra è la “Ca’ de Baciccia”
y
Le prime che ricordo sono le “scialle”* di mia madre Pinuccia.
A tre o quattro anni, non avendo altro con cui giocare, avevo preso l’abitudine di salire sul muro di una fascia di ulivi che correva parallelo alla corda sulla quale mia madre stendeva il bucato; sporgendomi prendevo un fazzoletto, lo infilzavo al centro su uno stecco o su una canna secca e lo facevo volteggiare, immaginandomi non bandiere, che non sapevo cosa fossero, ma ali di uccelli e farfalle fantastiche.
I fazzoletti di lino, orlati e con le iniziali delle mamme o delle nonne ricamate a punto croce, erano però preziosi e si usavano per generazioni rammendandoli con cura e conservandoli nel comò con i fiori di lavanda secchi.
Ogni giorno di bucato quindi erano botte.
Poiché, malgrado le scialle proseguivo nel gioco, questa fase durò per un anno o due sino a quando trovai la molla di una vecchia sveglia che, infilata su un pezzo di legno a mò di manubrio, mi faceva percorrere in motocicletta, come la Guzzi dello zio Giggiu, i sentieri attorno a Rollo e costituì per l’anno successivo il divertimento sostitutivo ai buchi nei fazzoletti.
Giunse poi la passione per i nidi di uccelli che sino al quarantacinque allietò le mie primavere e riempì le casseruole di Pinuccia e l’amore per le bisce che mordevano appena facendo il solletico, non come i “langoi”** che piantavano i denti facendo uscire il sangue.
Arrivai a conoscere le uova, il sistema e i luoghi di nidificazione, il periodo di cova ed il tempo medio di sviluppo di ogni specie che nidificava nella zona, oltre naturalmente ad ogni albero, cespuglio e rudere nei dintorni di Rollo ed ogni tipo di biscia della zona.
* sculacciate
** ramarri
A tre o quattro anni, non avendo altro con cui giocare, avevo preso l’abitudine di salire sul muro di una fascia di ulivi che correva parallelo alla corda sulla quale mia madre stendeva il bucato; sporgendomi prendevo un fazzoletto, lo infilzavo al centro su uno stecco o su una canna secca e lo facevo volteggiare, immaginandomi non bandiere, che non sapevo cosa fossero, ma ali di uccelli e farfalle fantastiche.
I fazzoletti di lino, orlati e con le iniziali delle mamme o delle nonne ricamate a punto croce, erano però preziosi e si usavano per generazioni rammendandoli con cura e conservandoli nel comò con i fiori di lavanda secchi.
Ogni giorno di bucato quindi erano botte.
Poiché, malgrado le scialle proseguivo nel gioco, questa fase durò per un anno o due sino a quando trovai la molla di una vecchia sveglia che, infilata su un pezzo di legno a mò di manubrio, mi faceva percorrere in motocicletta, come la Guzzi dello zio Giggiu, i sentieri attorno a Rollo e costituì per l’anno successivo il divertimento sostitutivo ai buchi nei fazzoletti.
Giunse poi la passione per i nidi di uccelli che sino al quarantacinque allietò le mie primavere e riempì le casseruole di Pinuccia e l’amore per le bisce che mordevano appena facendo il solletico, non come i “langoi”** che piantavano i denti facendo uscire il sangue.
Arrivai a conoscere le uova, il sistema e i luoghi di nidificazione, il periodo di cova ed il tempo medio di sviluppo di ogni specie che nidificava nella zona, oltre naturalmente ad ogni albero, cespuglio e rudere nei dintorni di Rollo ed ogni tipo di biscia della zona.
* sculacciate
** ramarri
Gialì accompagnò la mia infanzia dai primi ricordi sino al millenovecentoquarantacinque, quando andammo ad abitare ad Alassio.
Semmai un animale verrà beatificato questa capra sarà senz’altro la prescelta, perché in quegli anni ha sopportato con pazienza e sottomissione ogni sorta di soprusi, angherie, botte, insulti e trascuratezze, compresi furti di latte che bevevo, sdraiato in terra, schizzandolo in bocca direttamente dalle sue mammelle. Poco perché altrimenti Pinuccia, mungendola, se ne accorgeva.
Però fu anche causa di legnate toccate a me.
Un pomeriggio, dovendo andare in un uliveto chiamato “U Mea” a controllare se i nidiacei di cardellini e di merlo da scoglio avessero già messo le piume, legai Gialì in un uliveto detto “dalla Madonna” perché lei era lenta e voleva pascolare.
Al tramonto ritornai a prenderla ma il nodo si era sciolto e Gialì non c’era più; dopo averla cercata un po’ tornai a casa per cena.
Giumìn, mio padre, prima di farmi entrare mi chiese “dund’a l’è a crova ?”* e, alla mia risposta, che “era scappata” riaccostò la porta e mi intimò di non presentarmi se non trovavo la capra.
Avevo circa nove anni ed era buio, ma la paura delle botte di mio padre era più forte di ogni altra così percorsi tutti gli antichi sentieri che da Rollo portavano verso Conna.
Trovai Gialì sopra Stampino dopo San Giovanni verso mezzanotte perché, avendo un nodo all’estremità della corda che aveva al collo, era rimasta incastrata fra due pietre sporgenti dell’acciottolato e la sentivo belare dalla costa degli “Orti della Chiappa”. Ritornai a casa, legai Gialì nella stalla ed andai a letto senza cena per non svegliare Giumìn.
* dov’è la capra ?
Semmai un animale verrà beatificato questa capra sarà senz’altro la prescelta, perché in quegli anni ha sopportato con pazienza e sottomissione ogni sorta di soprusi, angherie, botte, insulti e trascuratezze, compresi furti di latte che bevevo, sdraiato in terra, schizzandolo in bocca direttamente dalle sue mammelle. Poco perché altrimenti Pinuccia, mungendola, se ne accorgeva.
Però fu anche causa di legnate toccate a me.
Un pomeriggio, dovendo andare in un uliveto chiamato “U Mea” a controllare se i nidiacei di cardellini e di merlo da scoglio avessero già messo le piume, legai Gialì in un uliveto detto “dalla Madonna” perché lei era lenta e voleva pascolare.
Al tramonto ritornai a prenderla ma il nodo si era sciolto e Gialì non c’era più; dopo averla cercata un po’ tornai a casa per cena.
Giumìn, mio padre, prima di farmi entrare mi chiese “dund’a l’è a crova ?”* e, alla mia risposta, che “era scappata” riaccostò la porta e mi intimò di non presentarmi se non trovavo la capra.
Avevo circa nove anni ed era buio, ma la paura delle botte di mio padre era più forte di ogni altra così percorsi tutti gli antichi sentieri che da Rollo portavano verso Conna.
Trovai Gialì sopra Stampino dopo San Giovanni verso mezzanotte perché, avendo un nodo all’estremità della corda che aveva al collo, era rimasta incastrata fra due pietre sporgenti dell’acciottolato e la sentivo belare dalla costa degli “Orti della Chiappa”. Ritornai a casa, legai Gialì nella stalla ed andai a letto senza cena per non svegliare Giumìn.
* dov’è la capra ?
Nel trentanove quando avevo sei anni morì il vecchio prete, che ricordo vagamente per la sua grossa pancia, e venne a Rollo un giovane pretino entusiasta che chiese a Pinuccia se mi poteva insegnare a servire Messa e diventare così chierichetto della parrocchia.
Pinuccia acconsentì ed io ero trepidante per il nuovo infinito orizzonte di esperienze che mi si prospettava.
Iniziai ad impratichirmi dell’ambiente bevendo il vino delle ampolline, bruciando tutto l’incenso del turibolo, salendo sul campanile per individuare eventuali nidi di passero ed inseguendo topi in sagrestia e nel coro dietro l’altare.
Don Dell’Erba e sua sorella Chiara mi accolsero in canonica e cominciarono ad istruirmi sui compiti di un chierichetto e ad insegnarmi a servire Messa, sicchè dopo un mese già “esercitavo” ed iniziai con la messa dei giorni feriali che allora si celebrava alle sei del mattino.
Pinuccia mi svegliava alle cinque e mezzo; scendevo a Rollo da Ca’ Bernei e servivo messa inginocchiato sui freddi gradini dell’altare, rispondendo al Kyrie, al Credo, al Gloria, al Sanctus, all’Ite come un ragazzo perbene e devoto.
Alla Messa, durante la settimana, partecipavano solitamente poche donne: Teejola, Maina, Camilìn, Teejin, Fiuìna, la moglie di Nanòlu che non ricordo come si chiamasse e Ninìn.
Ninìn era la madre della Maestra, moglie del Podestà.
Quando entrava Ninìn, anche se voltavo le spalle alla porta ed ero lontano dai banchi, me ne accorgevo subito perché quella povera vecchia, piegata ad angolo retto dall’artrosi, si faceva pipì addosso ed inoltre “presava” inalando polvere di tabacco dal naso come tutte le vecchie di Rollo solo che, avendo le mani deformate e semiparalizzate, non riusciva a pulirsi i moccoli marrone che le colavano dal naso.
Ninìn aveva un piccolo cagnolino bianco e nero e cieco che con l’olfatto la seguiva anche in chiesa e che il prete tollerava perché dormiva sempre e non abbaiava.
Pinuccia acconsentì ed io ero trepidante per il nuovo infinito orizzonte di esperienze che mi si prospettava.
Iniziai ad impratichirmi dell’ambiente bevendo il vino delle ampolline, bruciando tutto l’incenso del turibolo, salendo sul campanile per individuare eventuali nidi di passero ed inseguendo topi in sagrestia e nel coro dietro l’altare.
Don Dell’Erba e sua sorella Chiara mi accolsero in canonica e cominciarono ad istruirmi sui compiti di un chierichetto e ad insegnarmi a servire Messa, sicchè dopo un mese già “esercitavo” ed iniziai con la messa dei giorni feriali che allora si celebrava alle sei del mattino.
Pinuccia mi svegliava alle cinque e mezzo; scendevo a Rollo da Ca’ Bernei e servivo messa inginocchiato sui freddi gradini dell’altare, rispondendo al Kyrie, al Credo, al Gloria, al Sanctus, all’Ite come un ragazzo perbene e devoto.
Alla Messa, durante la settimana, partecipavano solitamente poche donne: Teejola, Maina, Camilìn, Teejin, Fiuìna, la moglie di Nanòlu che non ricordo come si chiamasse e Ninìn.
Ninìn era la madre della Maestra, moglie del Podestà.
Quando entrava Ninìn, anche se voltavo le spalle alla porta ed ero lontano dai banchi, me ne accorgevo subito perché quella povera vecchia, piegata ad angolo retto dall’artrosi, si faceva pipì addosso ed inoltre “presava” inalando polvere di tabacco dal naso come tutte le vecchie di Rollo solo che, avendo le mani deformate e semiparalizzate, non riusciva a pulirsi i moccoli marrone che le colavano dal naso.
Ninìn aveva un piccolo cagnolino bianco e nero e cieco che con l’olfatto la seguiva anche in chiesa e che il prete tollerava perché dormiva sempre e non abbaiava.
L'interno della Chiesa
Nell’estate del quaranta una notte stavo dormendo avendo finito di leggere, quando Giumìn mi svegliò, mi prese in braccio e mi portò sul terrazzo di Ca’ Bernei per vedere i lampi dei bombardamenti degli aerei francesi sul campo d’aviazione di Villanova d’ Albenga.
Proprio mentre stavamo guardando, dalla collina della Madonna della Guardia spuntò un aereo in fiamme, colpito dalla contraerea, che dopo aver percorso la valle del Merula passò, perdendo quota, davanti a Rollo e si inabissò in mare ad un chilometro o due dalla costa.
Quello fu il primo aereo che vidi; negli anni successivi divennero quotidiani i passaggi, prima dei nostri antiquati bombardieri in squadriglie di tre che andavano a bombardare l’Inghilterra, poi dei lenti aerei da ricognizione tedeschi chiamati cicogne, poi dei caccia inglesi, poi di Pippo ed infine di imponenti formazioni di fortezze volanti, scortate dai caccia, che si diceva andassero a bombardare Torino.
Una volta, in tre ondate successive, bombardarono il ponte ferroviario di Andora fortunatamente senza centrarlo; Gialì si nascose tremando in un ceppo di un grosso ulivo e non voleva più uscire; con Adriano contammo una novantina di crateri e raccogliemmo centinaia di schegge metalliche.
A Rollo quando per due giorni non si udiva il rombo di un aereo si pensava che fosse finita la guerra.
Non ho mai saputo se il pilota dell’aereo francese si sia salvato o sia ancora sepolto in mare di fronte Rollo.
Proprio mentre stavamo guardando, dalla collina della Madonna della Guardia spuntò un aereo in fiamme, colpito dalla contraerea, che dopo aver percorso la valle del Merula passò, perdendo quota, davanti a Rollo e si inabissò in mare ad un chilometro o due dalla costa.
Quello fu il primo aereo che vidi; negli anni successivi divennero quotidiani i passaggi, prima dei nostri antiquati bombardieri in squadriglie di tre che andavano a bombardare l’Inghilterra, poi dei lenti aerei da ricognizione tedeschi chiamati cicogne, poi dei caccia inglesi, poi di Pippo ed infine di imponenti formazioni di fortezze volanti, scortate dai caccia, che si diceva andassero a bombardare Torino.
Una volta, in tre ondate successive, bombardarono il ponte ferroviario di Andora fortunatamente senza centrarlo; Gialì si nascose tremando in un ceppo di un grosso ulivo e non voleva più uscire; con Adriano contammo una novantina di crateri e raccogliemmo centinaia di schegge metalliche.
A Rollo quando per due giorni non si udiva il rombo di un aereo si pensava che fosse finita la guerra.
Non ho mai saputo se il pilota dell’aereo francese si sia salvato o sia ancora sepolto in mare di fronte Rollo.
Anna la moglie di Angiulìn, ogni tanto organizzava una cena per i parenti o per i cacciatori amici del marito e siccome a Rollo negli anni quaranta non esisteva luce elettrica, mi chiedeva di portarle la cera che recuperavo dalla pulizia dei candelieri dell’altare.
Facendo fondere la cera e versandola in una sezione di canna precedentemente spaccata per inserirvi uno stoppino di spago e poi riaccostando e legando le due metà e lasciando raffreddare la cera, si otteneva una rudimentale candela.
Un giorno Anna mi disse di portarle molta cera perché Angiulìn aveva una riunione con gli amici; io andai in chiesa per ripulire i candelieri ma questi non contenevano che pochissima cera; mi ricordai allora che in un cassettone nella parte bassa del mobile della sacrestia avevo visto una enorme candela istoriata e dipinta che veniva esposta e brevemente accesa prima di Pasqua.
Trovarla, pestarla sino a ridurla in frammenti, riempire mezzo sacco da concime e portarlo ad Anna fu questione di un’ora.
Anna mi diede venti centesimi in rame di quelli con l’ape in rilievo.
Passarono i mesi; venne il periodo della Quaresima; il prete cercò la candela . . .
Ricordo quella Pasqua perché le presi dal prete, da sua sorella Chiara che faceva la perpetua, da Giumìn e persino da Battistìn de Fiuìna che faceva il sagrestano e che di solito mi proteggeva.
Facendo fondere la cera e versandola in una sezione di canna precedentemente spaccata per inserirvi uno stoppino di spago e poi riaccostando e legando le due metà e lasciando raffreddare la cera, si otteneva una rudimentale candela.
Un giorno Anna mi disse di portarle molta cera perché Angiulìn aveva una riunione con gli amici; io andai in chiesa per ripulire i candelieri ma questi non contenevano che pochissima cera; mi ricordai allora che in un cassettone nella parte bassa del mobile della sacrestia avevo visto una enorme candela istoriata e dipinta che veniva esposta e brevemente accesa prima di Pasqua.
Trovarla, pestarla sino a ridurla in frammenti, riempire mezzo sacco da concime e portarlo ad Anna fu questione di un’ora.
Anna mi diede venti centesimi in rame di quelli con l’ape in rilievo.
Passarono i mesi; venne il periodo della Quaresima; il prete cercò la candela . . .
Ricordo quella Pasqua perché le presi dal prete, da sua sorella Chiara che faceva la perpetua, da Giumìn e persino da Battistìn de Fiuìna che faceva il sagrestano e che di solito mi proteggeva.
Verso i primi di giugno, pochi giorni prima della fine della scuola, non ricordo se frequentavo la seconda o la terza elementare, stavo ritornando a Rollo dopo mezzogiorno per una scorciatoia detta “Baraccu”, che dall’attuale albergo Trieste portava alla sommità della “Muntò da Cruje”, quando vidi due grosse bisce uccellaie in amore che avevano formato, attorcigliandosi, una grossa palla che quasi non mi entrava nella cartella.
Riuscii comunque a prenderle e corsi a casa gridando trafelato: “Mamma, mamma, guarda cosa ti ho portato !” e tirai fuori le bisce che soffiando spaventate presero a strisciare sul pavimento e sotto il tavolo.
Le urla di Pinuccia schizzata al piano di sopra con gli occhi fuori dalle orbite fecero accorrere Giumìn.
Non so che fine abbiano fatto le mie bisce; io ricevetti la solita dose di “testaiùi”* e saltai pranzo e cena.
Un mese dopo in un nido di “caviùrne” che nidificano negli incavi del tronco degli ulivi trovai una bellissima biscia uccellaia di oltre un metro; memore di quanto era successo non la portai a casa ma cercai di farla giocare con Gialì.
Anche la capra però ebbe la stessa reazione di Pinuccia e dovetti rincorrerla sino quasi a Chiappa dall’altro versante della montagna. Dopo quest’ultimo esperimento decisi che con le bisce avrei giocato solo io e non le avrei più portate a nessuno.
Neanche a scuola !
* scappellotti o sberle tra orecchio e nuca
Riuscii comunque a prenderle e corsi a casa gridando trafelato: “Mamma, mamma, guarda cosa ti ho portato !” e tirai fuori le bisce che soffiando spaventate presero a strisciare sul pavimento e sotto il tavolo.
Le urla di Pinuccia schizzata al piano di sopra con gli occhi fuori dalle orbite fecero accorrere Giumìn.
Non so che fine abbiano fatto le mie bisce; io ricevetti la solita dose di “testaiùi”* e saltai pranzo e cena.
Un mese dopo in un nido di “caviùrne” che nidificano negli incavi del tronco degli ulivi trovai una bellissima biscia uccellaia di oltre un metro; memore di quanto era successo non la portai a casa ma cercai di farla giocare con Gialì.
Anche la capra però ebbe la stessa reazione di Pinuccia e dovetti rincorrerla sino quasi a Chiappa dall’altro versante della montagna. Dopo quest’ultimo esperimento decisi che con le bisce avrei giocato solo io e non le avrei più portate a nessuno.
Neanche a scuola !
* scappellotti o sberle tra orecchio e nuca
“Regordite che a Madonna a l’è chinò da u se pe’ina grona de so”.
Pinuccia, come tutte le donne di Rollo, aveva nei cromosomi il senso del risparmio e l’orrore per lo spreco e me lo trasmetteva con l’esempio e raccontandomi la favola della Madonna che, essendole caduto un grano di sale grosso, scese dal cielo e venne sulla terra a raccoglierlo.
Tutto in quegli anni veniva usato e sfruttato sino all’impossibile e quando un oggetto o un indumento diventava completamente inutilizzabile i suoi resti trovavano un diverso uso sotto altra forma:
gli abiti venivano trasformati in stracci da cucina e questi ultimi, quando erano talmente sfilacciati da non poter più essere utilizzati, venivano mescolati al letame e sepolti negli uliveti;
l’olio fritto e rifritto e quello che, malauguratamente, fosse irrancidito, veniva usato nei lumi e per lubrificare gli attrezzi da campagna;
i vari giornali che, come “La domenica del corriere” venivano comprati due o tre volte l’anno e la carta dei pacchetti della spesa fatta con i tagliandi della tessera annonaria, venivano usati per accendere la stufa e come carta igienica;
i rocchetti in legno del filo che Pinuccia usava per la macchina da cucire venivano trasformati da Giumìn in carri armati semoventi con l’aiuto di uno stecco e di un elastico e diventavano fantastici giocattoli per me ed Adriano;
le stecche degli ombrelli rotti diventavano archi con i quali giocare agli indiani;
le bottiglie, i fiaschi, le damigiane e le giare erano beni preziosi e venivano usati con la massima cura per non romperli e lasciarli alle generazioni successive; lo stesso criterio veniva applicato all’uso dei pochi mobili, delle posate, degli attrezzi per la campagna che, allora, costituivano tutto il patrimonio di una famiglia.
Persino le bucce delle patate venivano conservate ed usate come foraggio per le capre e per i conigli.
Sono le uniche bucce che ricordo non avendo mai pelato altro, né frutta né verdura e perché Pinuccia voleva che fossero finissime, quasi trasparenti.
Il cuore del cavolo veniva consumato crudo in insalata con qualche acciuga sotto sale; le foglie più esterne servivano per il minestrone e quelle perimetrali, verdi e coriacee, venivano utilizzate per fasciare i “previ” specie di involtini di pan grattato, uova, farina, patate, un “ricordo” di mortadella ed un pizzico di maggiorana cotti nel sugo di pomodoro.
Queste usanze avevano comunque un aspetto positivo: mai sentito parlare di rifiuti solidi urbani!
Pinuccia, come tutte le donne di Rollo, aveva nei cromosomi il senso del risparmio e l’orrore per lo spreco e me lo trasmetteva con l’esempio e raccontandomi la favola della Madonna che, essendole caduto un grano di sale grosso, scese dal cielo e venne sulla terra a raccoglierlo.
Tutto in quegli anni veniva usato e sfruttato sino all’impossibile e quando un oggetto o un indumento diventava completamente inutilizzabile i suoi resti trovavano un diverso uso sotto altra forma:
gli abiti venivano trasformati in stracci da cucina e questi ultimi, quando erano talmente sfilacciati da non poter più essere utilizzati, venivano mescolati al letame e sepolti negli uliveti;
l’olio fritto e rifritto e quello che, malauguratamente, fosse irrancidito, veniva usato nei lumi e per lubrificare gli attrezzi da campagna;
i vari giornali che, come “La domenica del corriere” venivano comprati due o tre volte l’anno e la carta dei pacchetti della spesa fatta con i tagliandi della tessera annonaria, venivano usati per accendere la stufa e come carta igienica;
i rocchetti in legno del filo che Pinuccia usava per la macchina da cucire venivano trasformati da Giumìn in carri armati semoventi con l’aiuto di uno stecco e di un elastico e diventavano fantastici giocattoli per me ed Adriano;
le stecche degli ombrelli rotti diventavano archi con i quali giocare agli indiani;
le bottiglie, i fiaschi, le damigiane e le giare erano beni preziosi e venivano usati con la massima cura per non romperli e lasciarli alle generazioni successive; lo stesso criterio veniva applicato all’uso dei pochi mobili, delle posate, degli attrezzi per la campagna che, allora, costituivano tutto il patrimonio di una famiglia.
Persino le bucce delle patate venivano conservate ed usate come foraggio per le capre e per i conigli.
Sono le uniche bucce che ricordo non avendo mai pelato altro, né frutta né verdura e perché Pinuccia voleva che fossero finissime, quasi trasparenti.
Il cuore del cavolo veniva consumato crudo in insalata con qualche acciuga sotto sale; le foglie più esterne servivano per il minestrone e quelle perimetrali, verdi e coriacee, venivano utilizzate per fasciare i “previ” specie di involtini di pan grattato, uova, farina, patate, un “ricordo” di mortadella ed un pizzico di maggiorana cotti nel sugo di pomodoro.
Queste usanze avevano comunque un aspetto positivo: mai sentito parlare di rifiuti solidi urbani!
Andora 1939: personale della Colonia d’Asti.
Pinuccia, la prima seduta a sinistra.
Pinuccia, la prima seduta a sinistra.

Natale, allora, arrivava solo una volta all’anno ed era preceduto da una novena in cui, alla sera, in chiesa a Rollo si cantava il “Regem Venturum Dominum” ed io mettevo la cotta pulita che Pinuccia mi aveva lavato con la “liscia”*.
Poi, alla messa di mezzanotte, si faceva nascere il Bambino e tutti lo baciavano e il mattino dopo c’era l’albero di Natale.
L’albero di Natale lo aspettavo da un anno all’altro perché era una pianta di ginepro infilata in una giara piena di pietre perché non si rovesciasse e, appesi ai rami del ginepro c’erano una dozzina di arance e mandarini ed una decina di caramelle che si chiamavano Elac.
Nelle “annàe” in quegli inverni cioè in cui il raccolto delle ulive era andato particolarmente bene, dall’albero pendevano anche due o tre torroncini minuscoli fasciati in una carta dorata con i margini frastagliati che si conservava per fare le figurine con le forbici.
Il collo della giara poi era coperto con qualche manciata di mandorle, noci e nocciole, ma parecchie erano rinsecchite.
La festa grande proseguiva poi a mezzogiorno perché Pinuccia preparava i “Tajaìn cu u tuccu”** e la cima con le uova sode dentro; alla fine c’era il panettone che Giumìn diceva che era genovese perché c’erano i canditi e lo zibibbo.
Un anno Giumìn tagliò una zucca secca e ci mise dentro una candela così che, di notte, sembrava uno che rideva sempre.
Poi, alla messa di mezzanotte, si faceva nascere il Bambino e tutti lo baciavano e il mattino dopo c’era l’albero di Natale.
L’albero di Natale lo aspettavo da un anno all’altro perché era una pianta di ginepro infilata in una giara piena di pietre perché non si rovesciasse e, appesi ai rami del ginepro c’erano una dozzina di arance e mandarini ed una decina di caramelle che si chiamavano Elac.
Nelle “annàe” in quegli inverni cioè in cui il raccolto delle ulive era andato particolarmente bene, dall’albero pendevano anche due o tre torroncini minuscoli fasciati in una carta dorata con i margini frastagliati che si conservava per fare le figurine con le forbici.
Il collo della giara poi era coperto con qualche manciata di mandorle, noci e nocciole, ma parecchie erano rinsecchite.
La festa grande proseguiva poi a mezzogiorno perché Pinuccia preparava i “Tajaìn cu u tuccu”** e la cima con le uova sode dentro; alla fine c’era il panettone che Giumìn diceva che era genovese perché c’erano i canditi e lo zibibbo.
Un anno Giumìn tagliò una zucca secca e ci mise dentro una candela così che, di notte, sembrava uno che rideva sempre.
Chiara la sorella del prete Grillo Nero, così soprannominato da Adriano, da un famoso personaggio del corriere dei piccoli, aveva la passione degli animali ed oltre a tenere nel pollaio sottostante la canonica una dozzina di galline e di conigli, curava con amore un paio di canarini in due gabbiette sotto il portico di ingresso alla canonica.
Dopo pranzo prendeva due croste di pane avanzato apposta per loro, lo inzuppava d’acqua e lo premeva contro le sbarrette delle gabbie lasciandovelo in modo che i canarini, beccandolo, potessero sfamarsi e dissetarsi contemporaneamente non esistendo allora mangime per gli uccelli.
Siccome neppure per me esisteva mangime sufficiente malgrado gli sforzi di Pinuccia, quando Chiara e Grillo Nero si allontanavano, mi avvicinavo alle gabbie e con aria indifferente afferravo le croste ormai asciutte e me le mangiavo con gusto.
Mai nessuno si accorse della cosa ed i canarini sopravvissero comunque, evitandomi così le solite botte ed il rimorso di aver abbreviato la loro già breve vita.
La parrocchia, cioè il prete, possedeva anche un uliveto in cui era cresciuto un enorme fico d’india; un’estate, resomi conto del fatto, andai a rubare i fichi d’india solo che, non conoscendoli, me li misi in seno tra la pelle e la canottiera.
Forse quella fu la punizione per aver rubato il pane ai canarini.
Dopo pranzo prendeva due croste di pane avanzato apposta per loro, lo inzuppava d’acqua e lo premeva contro le sbarrette delle gabbie lasciandovelo in modo che i canarini, beccandolo, potessero sfamarsi e dissetarsi contemporaneamente non esistendo allora mangime per gli uccelli.
Siccome neppure per me esisteva mangime sufficiente malgrado gli sforzi di Pinuccia, quando Chiara e Grillo Nero si allontanavano, mi avvicinavo alle gabbie e con aria indifferente afferravo le croste ormai asciutte e me le mangiavo con gusto.
Mai nessuno si accorse della cosa ed i canarini sopravvissero comunque, evitandomi così le solite botte ed il rimorso di aver abbreviato la loro già breve vita.
La parrocchia, cioè il prete, possedeva anche un uliveto in cui era cresciuto un enorme fico d’india; un’estate, resomi conto del fatto, andai a rubare i fichi d’india solo che, non conoscendoli, me li misi in seno tra la pelle e la canottiera.
Forse quella fu la punizione per aver rubato il pane ai canarini.
La Canonica.
A piano terra l’ingresso all’oratorio dove visse Babolu;
al primo piano il terrazzo coperto con le gabbie dei canarini.
A piano terra l’ingresso all’oratorio dove visse Babolu;
al primo piano il terrazzo coperto con le gabbie dei canarini.
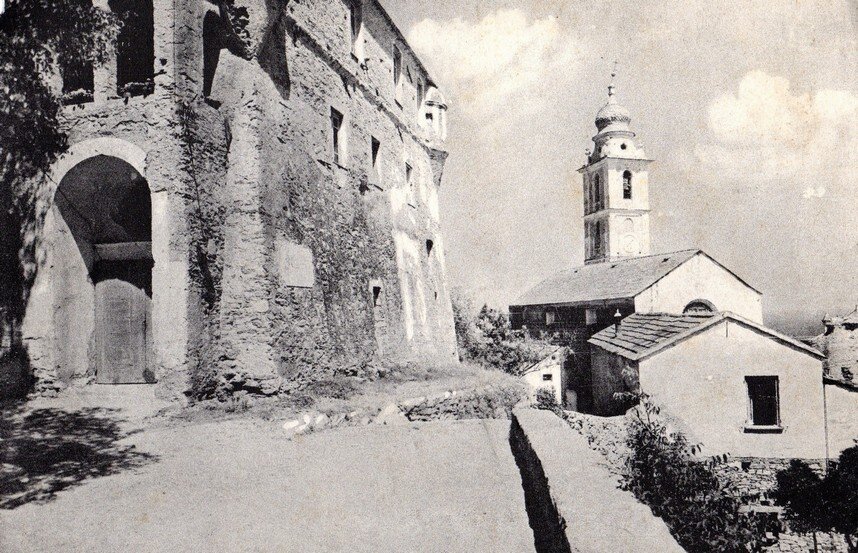
Nei primi anni di guerra era obbligatorio frequentare la casa del fascio durante il sabato fascista ed a noi ragazzini venivano impartite lezioni di combattimento simulato.
Un sabato ci condussero sulla scogliera ove attualmente sorge il ristorante “Rocce di Pinamare” esattamente lungo la liscia parete di roccia che costituisce il lato est della sala.
Dovevamo arrampicarci, strisciando con il “passo del giaguaro” sino all’Aurelia; la parete era tagliata longitudinalmente da grosse fessure che, essendosi col tempo riempite di terriccio e pietrame, avevano permesso lo sviluppo di un po’ di vegetazione e ci permettevano di riposare per qualche istante.
Stavo appunto sdraiato in una di queste fessure quando sentii Adriano* urlare come un pazzo e lo vidi precipitarsi giù dalla scarpata sino in mare: era finito in un nido di vespe ricevendo una mezza dozzina di punture!
Intervennero subito le crocerossine che erano le “piccole abissine” della colonia di Milano.
Dopo qualche mese ci diedero la divisa da “Balilla” con tanto di bandoliere e di fez col fiocco nero nonché un piccolo moschetto con baionetta incorporata.
Questa baionetta era una robusta asticella di ferro a sezione triangolare che veniva innestata con una torsione del polso e sporgeva di circa venti centimetri dall’estremità della canna.
Un pomeriggio l’avanguardista mi mise di piantone ad un vertice del perimetro che circondava l’area delle esercitazioni, sulla spiaggia di fronte all’attuale colonia di Milano, con l’ordine di “non far passare nessuno”.
Mi misi a percorrere col passo dell’oca e col moschetto a spallarm il tratto assegnatomi quando giunse un ragazzotto di tredici o quattordici anni, tale Chilé, che voleva entrare.
Passo, non passi, passo, non passi … quando mise piede nel perimetro gli diedi una baionettata nella coscia infilandogli tre centimetri di ferro nella carne.
Venne portato dal dottor Caviglia ed io venni promosso sul campo e ricevetti doppia razione di pastasciutta al rancio serale.
* Geometra Adriano Lunghi, stimato professionista ed ottima persona.
Un sabato ci condussero sulla scogliera ove attualmente sorge il ristorante “Rocce di Pinamare” esattamente lungo la liscia parete di roccia che costituisce il lato est della sala.
Dovevamo arrampicarci, strisciando con il “passo del giaguaro” sino all’Aurelia; la parete era tagliata longitudinalmente da grosse fessure che, essendosi col tempo riempite di terriccio e pietrame, avevano permesso lo sviluppo di un po’ di vegetazione e ci permettevano di riposare per qualche istante.
Stavo appunto sdraiato in una di queste fessure quando sentii Adriano* urlare come un pazzo e lo vidi precipitarsi giù dalla scarpata sino in mare: era finito in un nido di vespe ricevendo una mezza dozzina di punture!
Intervennero subito le crocerossine che erano le “piccole abissine” della colonia di Milano.
Dopo qualche mese ci diedero la divisa da “Balilla” con tanto di bandoliere e di fez col fiocco nero nonché un piccolo moschetto con baionetta incorporata.
Questa baionetta era una robusta asticella di ferro a sezione triangolare che veniva innestata con una torsione del polso e sporgeva di circa venti centimetri dall’estremità della canna.
Un pomeriggio l’avanguardista mi mise di piantone ad un vertice del perimetro che circondava l’area delle esercitazioni, sulla spiaggia di fronte all’attuale colonia di Milano, con l’ordine di “non far passare nessuno”.
Mi misi a percorrere col passo dell’oca e col moschetto a spallarm il tratto assegnatomi quando giunse un ragazzotto di tredici o quattordici anni, tale Chilé, che voleva entrare.
Passo, non passi, passo, non passi … quando mise piede nel perimetro gli diedi una baionettata nella coscia infilandogli tre centimetri di ferro nella carne.
Venne portato dal dottor Caviglia ed io venni promosso sul campo e ricevetti doppia razione di pastasciutta al rancio serale.
* Geometra Adriano Lunghi, stimato professionista ed ottima persona.
A cavallo degli anni trenta-quaranta la gente a Rollo si alzava al buio prima dell’alba ed andava a letto con le galline accendendo, per le poche ore necessarie, la “lümèa” che era un lume ad olio costituito da un’asticella cilindrica in ottone su di una base a forma varia con un contenitore di olio a tre beccucci dai quali sporgevano gli stoppini e che scorreva, regolabile in altezza, lungo l’asta.
Nelle case dei ricchi la “lümèa” era corredata da un anello con tre o quattro catenine dalle quali pendevano le forbicine per regolare lo stoppino, le pinzette per estrarlo dal beccuccio, il cono per spegnerlo, un grosso filo in rame per pulire i beccucci.
Normalmente si usava come combustibile l’olio rancido o quello di frittura dopo che era stato usato almeno una dozzina di volte.
Quando imparai a leggere divenni subito Salgari-dipendente tale da conoscere a memoria le avventure dei pescatori di Trepang, di Sandokan, Yanez, Kammamuri, del Corsaro Nero e dei suoi fratelli, nonché innumerevoli racconti di orchi, maghi, streghe, coboldi, fate e compagnia.
Riuscivo anche a leggere, prelevandoli dal cassetto del comò di Giumìn, i romanzi proibiti di Pitigrilli.
Non avendo abbastanza tempo durante il giorno aspettavo che Giumìn e Pinuccia andassero a dormire poi scendevo a riempire d’olio la lümèa nella giara della cucina, e questo anche tre volte per notte, leggendo a volte sino a quando sentivo cantare i galli.
I prelievi si ripeterono per molti mesi sino a quando Pinuccia si accorse che il livello dell’olio nella giara calava in maniera sospetta così, dopo qualche controllo, mi fecero dire la verità.
Al solito ricevetti una robusta dose di “testaiùi” nonché il divieto di prelevare olio dalla giara pena una non ben specificata ma consistente quantità di legnate.
Negli anni successivi alcune famiglie di progressisti adottarono un nuovo sistema di illuminazione: l’acetilene a base di carburo, ma la maggior parte dei vecchi conservatori tradizionalisti, sostenuti dal parere del saggio Chicottu, secondo il quale “sta lüje a l’è troppu forte e a fa mò ai öggi”* respinse l’innovazione.
Naturalmente Adriano ed io adottammo subito il sistema inventando una bomba costituita da una bottiglia a chiusura stagna di quelle col tappo ed il dischetto di gomma riempita con qualche pezzetto di carburo, poche gocce d’acqua e subito chiusa.
Dopo pochi secondi la pressione faceva esplodere la bottiglia e spargeva schegge di vetro nel raggio di dieci metri come una vera bomba ed il nuovo sistema sostituì le antiquate bombe, costituite da boccettini da inchiostro pieni di cenere, che Adriano ed io avevamo in dotazione.
La novità venne sperimentata nella canna fumaria del Bainòttu che immediatamente, come da istruzioni ricevute, andò a riferire a Giumìn che gli avevamo rovinato cucina e minestrone.
Il finale fu quello già collaudato con in più il dover portare al Bainòttu la mia cena.
* questa luce è troppo forte e fà male agli occhi.
Nelle case dei ricchi la “lümèa” era corredata da un anello con tre o quattro catenine dalle quali pendevano le forbicine per regolare lo stoppino, le pinzette per estrarlo dal beccuccio, il cono per spegnerlo, un grosso filo in rame per pulire i beccucci.
Normalmente si usava come combustibile l’olio rancido o quello di frittura dopo che era stato usato almeno una dozzina di volte.
Quando imparai a leggere divenni subito Salgari-dipendente tale da conoscere a memoria le avventure dei pescatori di Trepang, di Sandokan, Yanez, Kammamuri, del Corsaro Nero e dei suoi fratelli, nonché innumerevoli racconti di orchi, maghi, streghe, coboldi, fate e compagnia.
Riuscivo anche a leggere, prelevandoli dal cassetto del comò di Giumìn, i romanzi proibiti di Pitigrilli.
Non avendo abbastanza tempo durante il giorno aspettavo che Giumìn e Pinuccia andassero a dormire poi scendevo a riempire d’olio la lümèa nella giara della cucina, e questo anche tre volte per notte, leggendo a volte sino a quando sentivo cantare i galli.
I prelievi si ripeterono per molti mesi sino a quando Pinuccia si accorse che il livello dell’olio nella giara calava in maniera sospetta così, dopo qualche controllo, mi fecero dire la verità.
Al solito ricevetti una robusta dose di “testaiùi” nonché il divieto di prelevare olio dalla giara pena una non ben specificata ma consistente quantità di legnate.
Negli anni successivi alcune famiglie di progressisti adottarono un nuovo sistema di illuminazione: l’acetilene a base di carburo, ma la maggior parte dei vecchi conservatori tradizionalisti, sostenuti dal parere del saggio Chicottu, secondo il quale “sta lüje a l’è troppu forte e a fa mò ai öggi”* respinse l’innovazione.
Naturalmente Adriano ed io adottammo subito il sistema inventando una bomba costituita da una bottiglia a chiusura stagna di quelle col tappo ed il dischetto di gomma riempita con qualche pezzetto di carburo, poche gocce d’acqua e subito chiusa.
Dopo pochi secondi la pressione faceva esplodere la bottiglia e spargeva schegge di vetro nel raggio di dieci metri come una vera bomba ed il nuovo sistema sostituì le antiquate bombe, costituite da boccettini da inchiostro pieni di cenere, che Adriano ed io avevamo in dotazione.
La novità venne sperimentata nella canna fumaria del Bainòttu che immediatamente, come da istruzioni ricevute, andò a riferire a Giumìn che gli avevamo rovinato cucina e minestrone.
Il finale fu quello già collaudato con in più il dover portare al Bainòttu la mia cena.
* questa luce è troppo forte e fà male agli occhi.
Nell’anno millenovecentoquarantadue nella rada di Andora in prossimità di Capo Mele venne silurata una nave spagnola carica di arance.
Si venne poi a sapere, perché i palombari vennero a recuperarli lavorandoci alcuni mesi, che trasportava anche cinquecento motori per aerei da caccia.
Dopo qualche ora tutta la spiaggia dal torrente Merula a Capo Mele era cosparsa di arance che, libere o nelle casse, galleggiavano accostando a riva e tutta la gente accorse a raccoglierne a quintali mentre i pescatori con i “gussi”* andavano a soccorrere i naufraghi che urlavano.
Il mattino dopo, invece di andare a scuola, rifeci il giro trovando vicino alla foce del Merula un grosso delfino moribondo forse per le esplosioni dei siluri del giorno prima.
Dimenticai di aver marinato la scuola ed andai a chiamare Giumìn che immediatamente iniziò a macellarlo per farne carne da cuocere e “musciàme”** per il “cundiùn” che è una complessa insalata a base di pomodori:
Intanto si era radunata gente e mentre Giumìn terminava il lavoro giunse il Podestà con i fascisti della colonia che requisirono il tutto per l’ammasso pubblico.
Riuscii a nascondere solo due grossi filetti per il “musciàme” tra le budella da buttare.
Giumìn, quando li recuperai, dopo che tutti erano andati via, sbavava ancora dalla rabbia ma non me le suonò anche se non ero andato a scuola.
Si venne poi a sapere, perché i palombari vennero a recuperarli lavorandoci alcuni mesi, che trasportava anche cinquecento motori per aerei da caccia.
Dopo qualche ora tutta la spiaggia dal torrente Merula a Capo Mele era cosparsa di arance che, libere o nelle casse, galleggiavano accostando a riva e tutta la gente accorse a raccoglierne a quintali mentre i pescatori con i “gussi”* andavano a soccorrere i naufraghi che urlavano.
Il mattino dopo, invece di andare a scuola, rifeci il giro trovando vicino alla foce del Merula un grosso delfino moribondo forse per le esplosioni dei siluri del giorno prima.
Dimenticai di aver marinato la scuola ed andai a chiamare Giumìn che immediatamente iniziò a macellarlo per farne carne da cuocere e “musciàme”** per il “cundiùn” che è una complessa insalata a base di pomodori:
Intanto si era radunata gente e mentre Giumìn terminava il lavoro giunse il Podestà con i fascisti della colonia che requisirono il tutto per l’ammasso pubblico.
Riuscii a nascondere solo due grossi filetti per il “musciàme” tra le budella da buttare.
Giumìn, quando li recuperai, dopo che tutti erano andati via, sbavava ancora dalla rabbia ma non me le suonò anche se non ero andato a scuola.
Babòlu, in lingua italiana scarafaggio, era un cane spinone senza padrone che viveva a Rollo e mangiava da chi gliene dava e che i cacciatori utilizzavano per la caccia alla lepre.
Lo ricordo bene perché con Gialì al pascolo a volte lo incontravo sulle colline e mi seguiva per un po’ giocando con la capra.
Una notte Angeòttu, forse scambiandolo per la lepre gli sparò una fucilata in testa. Lo portarono dal dottor Caviglia che riuscì a salvargli la vita ma ne uscì completamente cieco; rimase a vivere qualche anno in piazza a Rollo dormendo nell’oratorio sotto la canonica dove oggi c’è il presepe, poi sparì.
Nel quarantacinque andammo ad abitare ad Alassio in via Solva ed iniziai a frequentare le medie dai Salesiani; un giorno, tornando a casa lungo l’Aurelia vicino al municipio vidi un cane che assomigliava a Babòlu.
Mi avvicinai e lo chiamai “Babòlu!”. Immediatamente si irrigidì, inizio a tremare ed a perdere pipì.
Con pazienza mi feci seguire sino a casa.
Babòlu visse i suoi ultimi anni vicino a casa nostra, mangiando felice e scodinzolando ogni volta che mi sentiva vicino.
Lo ricordo bene perché con Gialì al pascolo a volte lo incontravo sulle colline e mi seguiva per un po’ giocando con la capra.
Una notte Angeòttu, forse scambiandolo per la lepre gli sparò una fucilata in testa. Lo portarono dal dottor Caviglia che riuscì a salvargli la vita ma ne uscì completamente cieco; rimase a vivere qualche anno in piazza a Rollo dormendo nell’oratorio sotto la canonica dove oggi c’è il presepe, poi sparì.
Nel quarantacinque andammo ad abitare ad Alassio in via Solva ed iniziai a frequentare le medie dai Salesiani; un giorno, tornando a casa lungo l’Aurelia vicino al municipio vidi un cane che assomigliava a Babòlu.
Mi avvicinai e lo chiamai “Babòlu!”. Immediatamente si irrigidì, inizio a tremare ed a perdere pipì.
Con pazienza mi feci seguire sino a casa.
Babòlu visse i suoi ultimi anni vicino a casa nostra, mangiando felice e scodinzolando ogni volta che mi sentiva vicino.
Lùensu* era un vecchio alto e magrissimo che abitava in un rudere di Cae Suttàe senza vetri alle finestre, dopo la casa di Nanòlu.
Dicevano che era venuto chissà da dove a lavorare per la ferrovia quando era in costruzione alla fine dell’ottocento e poi si era fermato a Rollo.
Possedeva un logoro paio di pantaloni, un vecchio cappotto sdruscito che metteva in inverno ed una camicia che era tutta un rappezzo e che lui continuava a rammendare facendosi prestare ago, filo e uovo di legno da Pinuccia finchè Giumìn gli regalò una sua vecchia camicia che al paragone pareva un Trussardi.
Luènsu possedeva anche una bibbia e tre conigli che vivevano in casa con lui e un “beriùn” che era un attrezzo formato da cinque o sei grossi bastoni di legno collegati da corde e che serviva per avvolgere erba o fieno in un grosso fascio per trasportarlo dagli uliveti alle stalle.
Quando lo incontravo col suo beriùn di fieno per i conigli, mentre andavo a pascolare Gialì sulle colline attorno a Rollo, accostava la schiena ad un muro, appoggiando il fieno sulla fascia soprastante e mi raccontava di aver sognato che era morto e che era andato all’inferno per i suoi peccati ma che una signora con un vestito celeste lo chiamava “LUENSU …”.
E lo prendeva per mano portandolo in paradiso.
Io lo ascoltavo attonito e gli chiedevo sempre dove abitava la Signora perché “non si sa mai” come diceva Giumìn, ma Luènsu non me lo ha mai detto.
Chissà se la Signora lo ha poi chiamato e se va ancora a fare l’erba per i suoi conigli.
* Lorenzo
Dicevano che era venuto chissà da dove a lavorare per la ferrovia quando era in costruzione alla fine dell’ottocento e poi si era fermato a Rollo.
Possedeva un logoro paio di pantaloni, un vecchio cappotto sdruscito che metteva in inverno ed una camicia che era tutta un rappezzo e che lui continuava a rammendare facendosi prestare ago, filo e uovo di legno da Pinuccia finchè Giumìn gli regalò una sua vecchia camicia che al paragone pareva un Trussardi.
Luènsu possedeva anche una bibbia e tre conigli che vivevano in casa con lui e un “beriùn” che era un attrezzo formato da cinque o sei grossi bastoni di legno collegati da corde e che serviva per avvolgere erba o fieno in un grosso fascio per trasportarlo dagli uliveti alle stalle.
Quando lo incontravo col suo beriùn di fieno per i conigli, mentre andavo a pascolare Gialì sulle colline attorno a Rollo, accostava la schiena ad un muro, appoggiando il fieno sulla fascia soprastante e mi raccontava di aver sognato che era morto e che era andato all’inferno per i suoi peccati ma che una signora con un vestito celeste lo chiamava “LUENSU …”.
E lo prendeva per mano portandolo in paradiso.
Io lo ascoltavo attonito e gli chiedevo sempre dove abitava la Signora perché “non si sa mai” come diceva Giumìn, ma Luènsu non me lo ha mai detto.
Chissà se la Signora lo ha poi chiamato e se va ancora a fare l’erba per i suoi conigli.
* Lorenzo
In basso a destra il rudere in cui visse Luènsu.
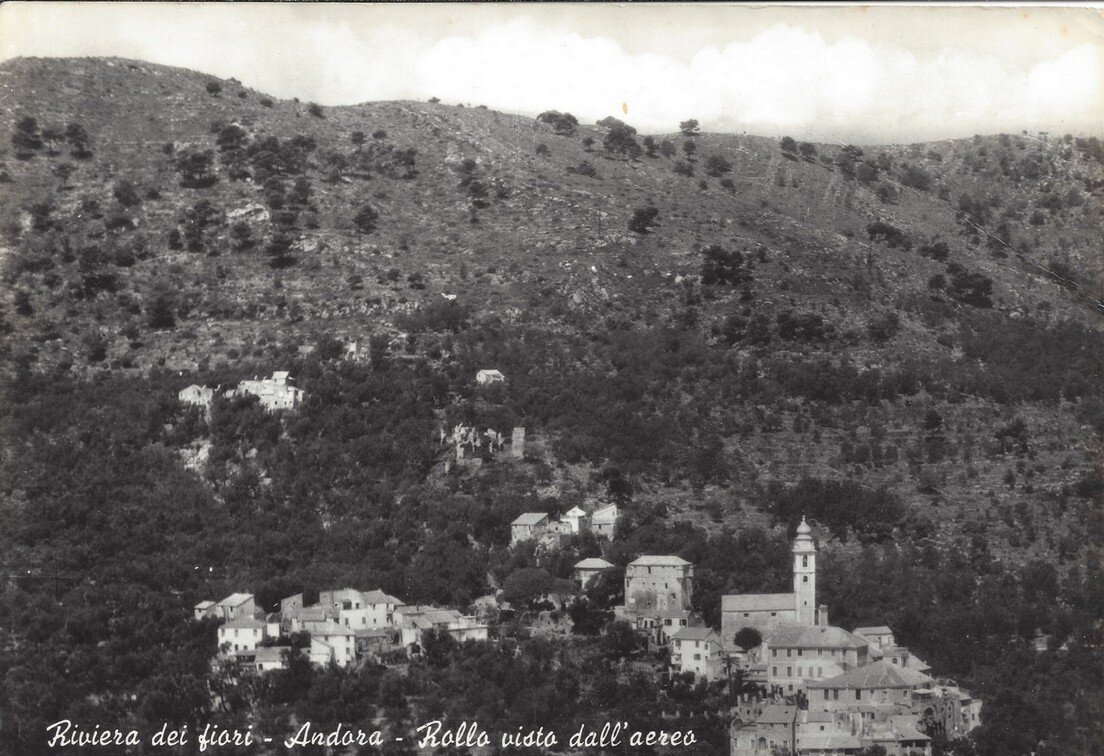
Nel quarantatre i tedeschi avevano costituito un deposito di materiale militare vicino ad un canneto ad Andora presso il ponte romano.
Tra gli esplosivi vi era, al bordo del canneto, una pila di centinaia di mine anticarro consistenti ognuna in una cassetta in legno con i manici di corda, contenente nove blocchi di tritolo fasciati in carta nera, con i quattro blocchi ai vertici già forati per l’innesto dei detonanti sia del tipo a miccia che di quelli a percussione.
Da Rollo, passando per un sentiero chiamato “du Bevüu” che da Ca’ Bernei portava al passaggio a livello, dove oggi sorge l’attuale consorzio agrario, mi incontravo con Adriano e con Giovanni; andavamo al deposito e nascosti nel canneto aspettavamo che le due sentinelle fossero all’estremità del perimetro, strisciavamo sino alle mine, afferravamo due cassette e via nel canneto.
In poche settimane avevamo accumulato diversi quintali di esplosivo, tanto da far saltare una brigata di carri armati.
Siccome Adriano e Giovanni abitavano ad Andora e quindi più vicini al malloppo, avevo paura che mi rubassero la mia parte di mine, perciò facendo una dozzina di viaggi, le trasportai a Rollo e, non sapendo dove nasconderle dato il volume, impilai tutto il tritolo sotto il mio lettino.
Eravamo in inverno e quella sera Giumìn passando in camera mia mi rimboccò le coperte, vide le mine, impallidì e … quando riuscii a scappare, pesto e sanguinante, mi rifugiai in una casella di pietra sopra Bande de Là, vicino alla strada della Colla e vi dormii per alcune notti.
Pinuccia, di nascosto quando Giumìn era al lavoro, mi portava un poco di minestra ed un pezzo di pane; ritornai a casa la settimana successiva per intercessione del prete, ma non ho mai chiesto a Giumìn dove avesse messo il mio tritolo.
Neanche da grande.
Tra gli esplosivi vi era, al bordo del canneto, una pila di centinaia di mine anticarro consistenti ognuna in una cassetta in legno con i manici di corda, contenente nove blocchi di tritolo fasciati in carta nera, con i quattro blocchi ai vertici già forati per l’innesto dei detonanti sia del tipo a miccia che di quelli a percussione.
Da Rollo, passando per un sentiero chiamato “du Bevüu” che da Ca’ Bernei portava al passaggio a livello, dove oggi sorge l’attuale consorzio agrario, mi incontravo con Adriano e con Giovanni; andavamo al deposito e nascosti nel canneto aspettavamo che le due sentinelle fossero all’estremità del perimetro, strisciavamo sino alle mine, afferravamo due cassette e via nel canneto.
In poche settimane avevamo accumulato diversi quintali di esplosivo, tanto da far saltare una brigata di carri armati.
Siccome Adriano e Giovanni abitavano ad Andora e quindi più vicini al malloppo, avevo paura che mi rubassero la mia parte di mine, perciò facendo una dozzina di viaggi, le trasportai a Rollo e, non sapendo dove nasconderle dato il volume, impilai tutto il tritolo sotto il mio lettino.
Eravamo in inverno e quella sera Giumìn passando in camera mia mi rimboccò le coperte, vide le mine, impallidì e … quando riuscii a scappare, pesto e sanguinante, mi rifugiai in una casella di pietra sopra Bande de Là, vicino alla strada della Colla e vi dormii per alcune notti.
Pinuccia, di nascosto quando Giumìn era al lavoro, mi portava un poco di minestra ed un pezzo di pane; ritornai a casa la settimana successiva per intercessione del prete, ma non ho mai chiesto a Giumìn dove avesse messo il mio tritolo.
Neanche da grande.
U Bainòttu era figlio del Baìn e della Baìna. Non ricodo il Baìn e vagamente intravvedo la figura della Baìna che, per una paresi, era immobilizzata su di una sedia che il Bainòttu portava tutti i giorni fuori casa su un poggioletto in pietra e che, legata alla sedia per non cadere biascicava: “Mangiò … mangiò … cramentu Maria”*.
Il Bainòttu vivendo solo dopo la morte della Baìna, in una vecchia casa tra i ruderi di Ca’ Bernei, era diventato un po’ strano e passava le sere infilando scaglie di pietra nelle fessure dei muri dei ruderi circostanti.
Adriano ed io ci divertivamo a disfare il suo lavoro togliendo le scaglie e tirandole con la fionda finchè un giorno il Bainòttu andò da mio padre a raccontargli le nostre imprese.
Giumìn non stava a considerare questo e quello e le conseguenze psicologiche e, come si diceva allora “mi unse come un cuoio”!
E lo stesso fece il padre di Adriano.
Il Bainòttu usava come cesso due giare interrate sotto un “autìn” che era un pergolato di viti posto nell’angolo tra la facciata di casa sua e quella di un rudere in pietra alto tre piani ed allora scoperchiato.
Siccome non esisteva il telefono azzurro al quale chiedere consiglio, anzi non esisteva neppure il telefono, Adriano ed io decidemmo il da farsi: due cubetti di tritolo con i detonanti a miccia, uno per giara, aprirono due enormi buche nel terreno sotto il pergolato, intonacando di fogna le facciate delle case sino al secondo piano.
Anche quella volta, dopo l’epica reazione di Giumìn, le presi da molta gente compreso il Bainòttu che era un tipo mite e compassato avendo fatto il militare.
* “Mangiare … mangiare … sacramento, Maria”.
Il Bainòttu vivendo solo dopo la morte della Baìna, in una vecchia casa tra i ruderi di Ca’ Bernei, era diventato un po’ strano e passava le sere infilando scaglie di pietra nelle fessure dei muri dei ruderi circostanti.
Adriano ed io ci divertivamo a disfare il suo lavoro togliendo le scaglie e tirandole con la fionda finchè un giorno il Bainòttu andò da mio padre a raccontargli le nostre imprese.
Giumìn non stava a considerare questo e quello e le conseguenze psicologiche e, come si diceva allora “mi unse come un cuoio”!
E lo stesso fece il padre di Adriano.
Il Bainòttu usava come cesso due giare interrate sotto un “autìn” che era un pergolato di viti posto nell’angolo tra la facciata di casa sua e quella di un rudere in pietra alto tre piani ed allora scoperchiato.
Siccome non esisteva il telefono azzurro al quale chiedere consiglio, anzi non esisteva neppure il telefono, Adriano ed io decidemmo il da farsi: due cubetti di tritolo con i detonanti a miccia, uno per giara, aprirono due enormi buche nel terreno sotto il pergolato, intonacando di fogna le facciate delle case sino al secondo piano.
Anche quella volta, dopo l’epica reazione di Giumìn, le presi da molta gente compreso il Bainòttu che era un tipo mite e compassato avendo fatto il militare.
* “Mangiare … mangiare … sacramento, Maria”.
I terreni circostanti Rollo, dalla ferrovia al crinale della collina e dal passo del Castellareto al confine di Cervo sino a Conna, dove la superficie non era roccia affiorante, nel corso dei secoli erano stati sistemati a terrazzi e piantumati ad uliveto.
Dicevano i vecchi che nei tempi andati a Rollo si contassero oltre trenta frantoi; io ne ricordo quattro a Ca’ Bernei ed uno a Ca’ Survone che però non erano più in funzione. Dicevano inoltre che nel settecento si contassero a Rollo oltre cento fuochi cioè cento famiglie per cui si può stimare la popolazione che allora viveva in paese sulle quattrocento persone.
A quei tempi negli uliveti, oltre agli ulivi, si piantavano molte specie di alberi da frutto i cui prodotti costituivano una importante componente della alimentazione degli abitanti.
Ricordo le razzie di nespole gialle e nespole marroni o giapponesi, di fichi neri e bianchi o brigiasssòtte*, di prugne viola e gialle, amarene, sorbole, giuggiole, mandorle sciaccaélle*, carrube e piccole pesche dolcissime che si spaccavano lasciando un nocciolo rosso pulito; e i corbezzoli che erano un lassativo tremendo.
Pur essendo già in decadenza, la coltivazione dell’ulivo negli anni trenta continuava alimentata dai vecchi che in gioventù avevano navigato e che da anziani, ritornati permanentemente a Rollo, cercavano per quanto possibile di ripristinare i muri a secco crollati, potare gli alberi troppo infoltiti ed applicare le vecchie tecniche di concimazione cioè le “sòtte” e i “furnélli”.
La “sòtta” consisteva in una fossa semicircolare larga circa un metro e profonda cinquanta centimetri scavata attorno al ceppo dell’ulivo, riempita con la sterpaglia falciata nelle fasce e ricoperta con la terra di scavo. Sulla sòtta si piantavano le fave.
I “furnélli” consistevano in trincee profonde quasi un metro e lunghe quanto la fascia, riempite con la minutaglia della potatura, perché il grosso si portava a casa per la stufa, e ricoperte con la terra di scavo lasciando libere le due estremità.
Accendendo la ramaglia ad una estremità si sviluppava un certo tiraggio che permetteva la combustione di tutto il materiale coperto; la terra soprastante veniva cotta assumendo un colore rossastro e con la cenere sottostante costituiva un ottimo fertilizzante.
Ricordo un vecchio, mi pare U Gin da Gramuò ma non sono sicuro, che lavorava in giornata e si era fatto fare dal fabbro una zappa speciale a quattro becchi che rivoltava zolle enormi.
La sera ritornava a casa, mangiava qualcosa e poi di notte andava nei suoi uliveti e, con un lumino ad olio in bocca per avere le mani libere, lavorava per rifare i muri a secco crollati.
Quando si sentì morire si cucì all’interno di un sacco e lo trovarono alcuni mesi dopo.
Per la frutta rubata non ho mai preso botte salvo che da Gigéttu perché gli fregavo le amarene con le quali sua madre Maìna faceva le marmellate.
* intraducibile
Dicevano i vecchi che nei tempi andati a Rollo si contassero oltre trenta frantoi; io ne ricordo quattro a Ca’ Bernei ed uno a Ca’ Survone che però non erano più in funzione. Dicevano inoltre che nel settecento si contassero a Rollo oltre cento fuochi cioè cento famiglie per cui si può stimare la popolazione che allora viveva in paese sulle quattrocento persone.
A quei tempi negli uliveti, oltre agli ulivi, si piantavano molte specie di alberi da frutto i cui prodotti costituivano una importante componente della alimentazione degli abitanti.
Ricordo le razzie di nespole gialle e nespole marroni o giapponesi, di fichi neri e bianchi o brigiasssòtte*, di prugne viola e gialle, amarene, sorbole, giuggiole, mandorle sciaccaélle*, carrube e piccole pesche dolcissime che si spaccavano lasciando un nocciolo rosso pulito; e i corbezzoli che erano un lassativo tremendo.
Pur essendo già in decadenza, la coltivazione dell’ulivo negli anni trenta continuava alimentata dai vecchi che in gioventù avevano navigato e che da anziani, ritornati permanentemente a Rollo, cercavano per quanto possibile di ripristinare i muri a secco crollati, potare gli alberi troppo infoltiti ed applicare le vecchie tecniche di concimazione cioè le “sòtte” e i “furnélli”.
La “sòtta” consisteva in una fossa semicircolare larga circa un metro e profonda cinquanta centimetri scavata attorno al ceppo dell’ulivo, riempita con la sterpaglia falciata nelle fasce e ricoperta con la terra di scavo. Sulla sòtta si piantavano le fave.
I “furnélli” consistevano in trincee profonde quasi un metro e lunghe quanto la fascia, riempite con la minutaglia della potatura, perché il grosso si portava a casa per la stufa, e ricoperte con la terra di scavo lasciando libere le due estremità.
Accendendo la ramaglia ad una estremità si sviluppava un certo tiraggio che permetteva la combustione di tutto il materiale coperto; la terra soprastante veniva cotta assumendo un colore rossastro e con la cenere sottostante costituiva un ottimo fertilizzante.
Ricordo un vecchio, mi pare U Gin da Gramuò ma non sono sicuro, che lavorava in giornata e si era fatto fare dal fabbro una zappa speciale a quattro becchi che rivoltava zolle enormi.
La sera ritornava a casa, mangiava qualcosa e poi di notte andava nei suoi uliveti e, con un lumino ad olio in bocca per avere le mani libere, lavorava per rifare i muri a secco crollati.
Quando si sentì morire si cucì all’interno di un sacco e lo trovarono alcuni mesi dopo.
Per la frutta rubata non ho mai preso botte salvo che da Gigéttu perché gli fregavo le amarene con le quali sua madre Maìna faceva le marmellate.
* intraducibile
Gigéttu era figlio di Maìna e di Pipìn de l’òa e fratello di Angiulìn e Giuseppina madre di Adriano ed Elio.
Gigéttu ed Angiulìn con Giumìn, Angeòttu e Giacumìn figlio di Chicòttu erano degli incancreniti cacciatori che sfidavano il coprifuoco dei tedeschi e dei San Marco per andare di notte alla posta alla lepre.
Alla sera si riunivano in casa nostra per caricare le cartucce con una macchinetta per l’orlo ed il bilancino per dosare la polvere ed i pallini.
La difficoltà stava nel reperire il piombo per i pallini.
In quegli anni i militari usavano come poligono di tiro la costa di “Mangiapàn” sparando ai bersagli lungo un muro sotto il “Fussàu de razze”; io andavo spesso tra i militari che mi avevano insegnato a smontare l’otturatore dei fucili e qualche volta il tenente mi faceva sparare ai bersagli con il moschetto.
Dopo i tiri andavo a cercare le pallottole spiaccicate contro il muro dietro i bersagli e le vendevo a Gigéttu.
Lui le faceva fondere in una padella separando il piombo liquido dai residui deformati delle pallottole in acciaio o in rame poi bucherellava con un chiodo una cartolina, si metteva sopra una pentola d’acqua fredda e piano piano versava il piombo fuso sulla cartolina; le gocce che dai fori cadevano nell’acqua fredda solidificavano formando i pallini per caricare le cartucce da lepre.
Terminate le esercitazioni dei militari un giorno sentii dire da qualcuno che le canne dell’organo della chiesa erano in lega di piombo.
Detto fatto, ogni volta che Gigéttu aveva bisogno di piombo prelevavo una canna dell’organo del seicento, la piegavo, la martellavo sino a ridurla ad un blocchetto compatto e lo vendevo a Gigéttu.
Fortunatamente in quegli anni nessuno suonava l’organo perché Grillo Nero aveva comprato un piccolo armonium che si suonava in coro e quindi nessuno si accorse che mancavano alcune canne dell’organo e, almeno per quel fatto, non le ho mai prese.
Gigéttu ed Angiulìn con Giumìn, Angeòttu e Giacumìn figlio di Chicòttu erano degli incancreniti cacciatori che sfidavano il coprifuoco dei tedeschi e dei San Marco per andare di notte alla posta alla lepre.
Alla sera si riunivano in casa nostra per caricare le cartucce con una macchinetta per l’orlo ed il bilancino per dosare la polvere ed i pallini.
La difficoltà stava nel reperire il piombo per i pallini.
In quegli anni i militari usavano come poligono di tiro la costa di “Mangiapàn” sparando ai bersagli lungo un muro sotto il “Fussàu de razze”; io andavo spesso tra i militari che mi avevano insegnato a smontare l’otturatore dei fucili e qualche volta il tenente mi faceva sparare ai bersagli con il moschetto.
Dopo i tiri andavo a cercare le pallottole spiaccicate contro il muro dietro i bersagli e le vendevo a Gigéttu.
Lui le faceva fondere in una padella separando il piombo liquido dai residui deformati delle pallottole in acciaio o in rame poi bucherellava con un chiodo una cartolina, si metteva sopra una pentola d’acqua fredda e piano piano versava il piombo fuso sulla cartolina; le gocce che dai fori cadevano nell’acqua fredda solidificavano formando i pallini per caricare le cartucce da lepre.
Terminate le esercitazioni dei militari un giorno sentii dire da qualcuno che le canne dell’organo della chiesa erano in lega di piombo.
Detto fatto, ogni volta che Gigéttu aveva bisogno di piombo prelevavo una canna dell’organo del seicento, la piegavo, la martellavo sino a ridurla ad un blocchetto compatto e lo vendevo a Gigéttu.
Fortunatamente in quegli anni nessuno suonava l’organo perché Grillo Nero aveva comprato un piccolo armonium che si suonava in coro e quindi nessuno si accorse che mancavano alcune canne dell’organo e, almeno per quel fatto, non le ho mai prese.
Rollo 1939: la Cresima.
a sinistra: Grillo Nero
a destra: la più alta è Pinuccia;
il cresimando con i pantaloni lunghi è l’autore.
a sinistra: Grillo Nero
a destra: la più alta è Pinuccia;
il cresimando con i pantaloni lunghi è l’autore.

Durante i primi anni delle elementari era diventato di moda ingozzare i bambini con l’olio di fegato di merluzzo che allora non era raffinato ed assomigliava sorprendentemente all’olio del motore di un’auto cambiato dal meccanico al controllo dei ventimila chilometri.
Ma il lato più raccapricciante della cosa non era l’aspetto bensì l’odore che ricordava una miscela di pesce marcio e pipì di gatto.
Ogni mattina bisognava ingoiarne un cucchiaio ed era un trauma che nel sonno mi procurava sudori freddi e conati di vomito.
Fortunatamente, negli ultimi tempi, l’orrenda pozione mi veniva servita da Pinuccia in una specie di ostia precedentemente ammollata in acqua; rimaneva pur sempre schifosa, ma sopportabile se l’ostia non si rompeva nel trangugiarla.
Quello però era solo un aspetto della medicina medioevale in uso a Rollo in quegli anni.
Il mal di pancia veniva curato con l’olio di ricino che, pur non raggiungendo l’orrore di quello di fegato, era pur sempre una atrocità da ingerire ed inoltre provocava improvvisi sconvolgimenti intestinali il che, col cesso in una giara a cinquanta metri da casa, diventava un problema logistico non indifferente.
Gli ematomi venivano curati con “impiastri” cioè pappine di semi di lino bolliti ed applicati bollenti sui lividi.
Il mal di denti con foglie di malva masticate crude e tenute in bocca per tutta la notte.
Il mal di testa con fette di patata poste sulla fronte e sulle tempie tenutevi con un fazzoletto legato al capo.
Il mal di stomaco con decotti di “gambarussa” o parietaria.
I vermi masticando ed ingerendo aglio crudo.
Il catarro con applicazioni sulla pelle di un cotone infernale detto Termogen e che aveva lo stesso effetto di carboni ardenti.
Uno dei metodi più praticati per curare il mal di schiena, il torcicollo ed altri malanni simili erano le “ventose”.
Il sistema consisteva nel fasciare una moneta con uno straccetto, legando con filo i quattro vertici sopra una faccia della moneta a modo di stoppino si inzuppava lo stoppino con olio, si accendeva e si posava la moneta sulla zona dolorante e si copriva con un bicchiere capovolto.
La fiammella consumava l’ossigeno sino a spegnersi creando una depressione e la carne sottostante si gonfiava creando una semisfera violacea che riempiva mezzo bicchiere bloccandolo.
Dopo qualche minuto la superficie della bolla si copriva di goccioline di liquido e piano piano la depressione spariva lasciando libero il bicchiere; pare che questa pratica riducesse considerevolmente il dolore.
Fu comunque in quegli anni che imparai l’arte di tacere e non lamentarmi mai per un dolore, avendo imparato che in ogni caso il rimedio era più doloroso del male.
Ma il lato più raccapricciante della cosa non era l’aspetto bensì l’odore che ricordava una miscela di pesce marcio e pipì di gatto.
Ogni mattina bisognava ingoiarne un cucchiaio ed era un trauma che nel sonno mi procurava sudori freddi e conati di vomito.
Fortunatamente, negli ultimi tempi, l’orrenda pozione mi veniva servita da Pinuccia in una specie di ostia precedentemente ammollata in acqua; rimaneva pur sempre schifosa, ma sopportabile se l’ostia non si rompeva nel trangugiarla.
Quello però era solo un aspetto della medicina medioevale in uso a Rollo in quegli anni.
Il mal di pancia veniva curato con l’olio di ricino che, pur non raggiungendo l’orrore di quello di fegato, era pur sempre una atrocità da ingerire ed inoltre provocava improvvisi sconvolgimenti intestinali il che, col cesso in una giara a cinquanta metri da casa, diventava un problema logistico non indifferente.
Gli ematomi venivano curati con “impiastri” cioè pappine di semi di lino bolliti ed applicati bollenti sui lividi.
Il mal di denti con foglie di malva masticate crude e tenute in bocca per tutta la notte.
Il mal di testa con fette di patata poste sulla fronte e sulle tempie tenutevi con un fazzoletto legato al capo.
Il mal di stomaco con decotti di “gambarussa” o parietaria.
I vermi masticando ed ingerendo aglio crudo.
Il catarro con applicazioni sulla pelle di un cotone infernale detto Termogen e che aveva lo stesso effetto di carboni ardenti.
Uno dei metodi più praticati per curare il mal di schiena, il torcicollo ed altri malanni simili erano le “ventose”.
Il sistema consisteva nel fasciare una moneta con uno straccetto, legando con filo i quattro vertici sopra una faccia della moneta a modo di stoppino si inzuppava lo stoppino con olio, si accendeva e si posava la moneta sulla zona dolorante e si copriva con un bicchiere capovolto.
La fiammella consumava l’ossigeno sino a spegnersi creando una depressione e la carne sottostante si gonfiava creando una semisfera violacea che riempiva mezzo bicchiere bloccandolo.
Dopo qualche minuto la superficie della bolla si copriva di goccioline di liquido e piano piano la depressione spariva lasciando libero il bicchiere; pare che questa pratica riducesse considerevolmente il dolore.
Fu comunque in quegli anni che imparai l’arte di tacere e non lamentarmi mai per un dolore, avendo imparato che in ogni caso il rimedio era più doloroso del male.
Carmelina era una vecchietta magra che abitava a Ca’ Tiaferi, vicino a Bacicìn de Lasagna ed era soprannominata “U Gaggiùn”*. Io chiedevo sempre ai vecchi perché la chiamavano così, ma quelli ridevano e non volevano spiegarmelo.
Finalmente Nanìn de Milia un giorno mi disse che era perché da giovane prendeva tutti gli uccelli che le passavano vicino e, alla mia richiesta di sapere come faceva, mi spiegò che metteva ad ogni uccello un pizzico di sale sulla coda e quello si fermava.
Andai subito a casa e siccome quell’estate avevo allevato tre cardellini, rubai un po’ di sale a Pinuccia, tirai fuori il primo cardellino, gli misi un pizzico di sale sulla coda, lo lasciai e quello volò via.
Pensando di aver sbagliato la dose, tirai fuori il secondo e lo copersi di sale, ma anche quello volò via.
Al terzo tentativo capii che Nanìn de Milia mi aveva fregato.
Per vendicarmi mi procurai un po’ di cacca di cane e con l’aiuto di uno stecco, gli riempii il buco della serratura del portone di casa.
* Il Gabbione.
Finalmente Nanìn de Milia un giorno mi disse che era perché da giovane prendeva tutti gli uccelli che le passavano vicino e, alla mia richiesta di sapere come faceva, mi spiegò che metteva ad ogni uccello un pizzico di sale sulla coda e quello si fermava.
Andai subito a casa e siccome quell’estate avevo allevato tre cardellini, rubai un po’ di sale a Pinuccia, tirai fuori il primo cardellino, gli misi un pizzico di sale sulla coda, lo lasciai e quello volò via.
Pensando di aver sbagliato la dose, tirai fuori il secondo e lo copersi di sale, ma anche quello volò via.
Al terzo tentativo capii che Nanìn de Milia mi aveva fregato.
Per vendicarmi mi procurai un po’ di cacca di cane e con l’aiuto di uno stecco, gli riempii il buco della serratura del portone di casa.
* Il Gabbione.
Dopo l’otto settembre quarantatrè quando i militari abbandonarono le caserme e prima che i nostri genitori bruciassero tutti gli esplosivi, nei locali della colonia dei poveri di Genova, ove attualmente sorge il condominio “Il Piccolo Parco” si trovava di tutto: dai caricatori di vari tipi di fucile, a quelli per la mitragliatrice Breda, dalle casse di bombe a mano Balilla, alle Sipe, ai razzi Bengala.
Naturalmente Adriano, Bruno, Totò il figlio della Sardegnola, Giuvanni du Bagnau ed io ci precipitammo a recuperare esplosivi perché dovevamo minare il tombino della “Muntò da Cruje”* per farlo saltare in caso di invasione.
Qualcuno, sparando un Bengala, che era un razzo da segnalazione e da illuminazione notturna, si accorse che l’arnese, formato da un tubo di cartone spesso e lungo oltre un metro, dal quale sporgeva la funicella da tirare o una specie di fiammifero da strofinare, conteneva un cilindro di fosforo appeso ad un paracadute di seta.
Fu appunto per recuperare uno di questi paracadute che successe il guaio.
Ci trovammo un pomeriggio con un bengala del tipo ad accensione a strappo nel bosco di stupendi pini marittimi che circondava un’antica chiesetta detta “La Concezione”, ove sorge oggi l’omonima cappella lungo la comunale per Rollo.
Essendo uno dei primi razzi che sparavamo, avevamo un certo timore, quindi al primo spago legammo altre cordicelle per una lunghezza di un paio di metri poi lo fissammo ad un albero cercando di metterlo verticale e cominciammo a dare strappi.
Dopo alcuni tentativi a vuoto il razzo esplose solo che, a seguito dei vari strappi, la sua posizione non era più verticale ma quasi orizzontale e finì in un cespuglio di ginestra secca che si incendiò immediatamente.
Dopo un quarto d’ora la pineta bruciava in un inferno di fuoco.
La gente accorse per spegnere le fiamme non essendoci i pompieri ma tutto fu inutile: alla sera l’intero bosco di pini era ridotto in cenere.
Naturalmente gli autori del disastro furono scoperti e si rividero la settimana dopo, quando i lividi delle legnate si erano ormai trasformati in macchie giallastre.
* tratto della mulattiera Rollo-Andora: Salita della Croce.
Naturalmente Adriano, Bruno, Totò il figlio della Sardegnola, Giuvanni du Bagnau ed io ci precipitammo a recuperare esplosivi perché dovevamo minare il tombino della “Muntò da Cruje”* per farlo saltare in caso di invasione.
Qualcuno, sparando un Bengala, che era un razzo da segnalazione e da illuminazione notturna, si accorse che l’arnese, formato da un tubo di cartone spesso e lungo oltre un metro, dal quale sporgeva la funicella da tirare o una specie di fiammifero da strofinare, conteneva un cilindro di fosforo appeso ad un paracadute di seta.
Fu appunto per recuperare uno di questi paracadute che successe il guaio.
Ci trovammo un pomeriggio con un bengala del tipo ad accensione a strappo nel bosco di stupendi pini marittimi che circondava un’antica chiesetta detta “La Concezione”, ove sorge oggi l’omonima cappella lungo la comunale per Rollo.
Essendo uno dei primi razzi che sparavamo, avevamo un certo timore, quindi al primo spago legammo altre cordicelle per una lunghezza di un paio di metri poi lo fissammo ad un albero cercando di metterlo verticale e cominciammo a dare strappi.
Dopo alcuni tentativi a vuoto il razzo esplose solo che, a seguito dei vari strappi, la sua posizione non era più verticale ma quasi orizzontale e finì in un cespuglio di ginestra secca che si incendiò immediatamente.
Dopo un quarto d’ora la pineta bruciava in un inferno di fuoco.
La gente accorse per spegnere le fiamme non essendoci i pompieri ma tutto fu inutile: alla sera l’intero bosco di pini era ridotto in cenere.
Naturalmente gli autori del disastro furono scoperti e si rividero la settimana dopo, quando i lividi delle legnate si erano ormai trasformati in macchie giallastre.
* tratto della mulattiera Rollo-Andora: Salita della Croce.
Andora 1930
Oratorio della Concezione.
A sinistra la pineta.
Oratorio della Concezione.
A sinistra la pineta.

A volte Giumìn, di ritorno dopo mesi di navigazione o, come si diceva a Rollo, dopo essere stato “imbarcàu” per alcuni mesi, portava a casa tra i regali per Pinuccia e per me, il “musciàme”.
Si trattava, allora, di un tipico prodotto dei pescatori del mediterraneo e dei naviganti sui velieri ed era costituito da un filetto di delfino che veniva appeso ad essiccare ed ogni tanto veniva irrorato di acqua di mare e strofinato con sale.
Oggi, col delfino fortunatamente protetto, è sostituito con filetto di tonno con una preparazione molto più veloce e commerciale.
Quando arrivava in casa il musciàme si preparava il cundiùn che non era solo pranzo, ma una vera cerimonia già dalla preparazione.
Si trattava infatti di una complessa insalata a base di pomodori ma i cui ingredienti, da mantenere scrupolosamente identificati, dosati e non sostituibili, dovevano essere affettati in un certo ordine prestabilito.
Il cundiùn si mangiava con parenti, amici o vicini di casa su di un tavolo rustico sotto un uliveto in un unico recipiente di coccio chiamato “jatta”.
Per il cundiùn non esistevano posate, ma ognuno intingeva nella “bagnetta”* una fetta di pane, portando in bocca, tra il pane e le dita, le fette di pomodoro, di sedano, di peperone, di cipolla, di cetriolo, di musciàme, mentre Giumìn narrava le sue avventure in mondi che io rivisitavo di notte.
Il cundiùn di Giumìn rivive a Rollo, ogni anno alla “Festa delle erbe”.
• Liquido formato dall’olio, dal sugo delle varie verdure e dall’aceto dei capperi
Si trattava, allora, di un tipico prodotto dei pescatori del mediterraneo e dei naviganti sui velieri ed era costituito da un filetto di delfino che veniva appeso ad essiccare ed ogni tanto veniva irrorato di acqua di mare e strofinato con sale.
Oggi, col delfino fortunatamente protetto, è sostituito con filetto di tonno con una preparazione molto più veloce e commerciale.
Quando arrivava in casa il musciàme si preparava il cundiùn che non era solo pranzo, ma una vera cerimonia già dalla preparazione.
Si trattava infatti di una complessa insalata a base di pomodori ma i cui ingredienti, da mantenere scrupolosamente identificati, dosati e non sostituibili, dovevano essere affettati in un certo ordine prestabilito.
Il cundiùn si mangiava con parenti, amici o vicini di casa su di un tavolo rustico sotto un uliveto in un unico recipiente di coccio chiamato “jatta”.
Per il cundiùn non esistevano posate, ma ognuno intingeva nella “bagnetta”* una fetta di pane, portando in bocca, tra il pane e le dita, le fette di pomodoro, di sedano, di peperone, di cipolla, di cetriolo, di musciàme, mentre Giumìn narrava le sue avventure in mondi che io rivisitavo di notte.
Il cundiùn di Giumìn rivive a Rollo, ogni anno alla “Festa delle erbe”.
• Liquido formato dall’olio, dal sugo delle varie verdure e dall’aceto dei capperi
Cesare de Carmelin era stato per alcuni anni mio compagno di banco alle elementari dalla maestra Gastaldi.
Quei vecchi cari, scomodi banchi delle elementari avevano un unico calamaio centrale costituito da un boccettino di inchiostro bloccato in un foro del banco e nel quale, attraverso lo stretto collo, si intingeva il pennino per scrivere.
Un mattino, senza farmene accorgere, presi una mosca e la buttai nel calamaio, poi tutto agitato dissi a Cesare: “U ghè ina musca in tu caamò; levila che mi a l’ho puia”*
Lui si mise a trafficare con la penna ma essendo il collo del calamaio più stretto del contenitore non riusciva a toglierla così gli suggerii ancora: “E sciuscighe nà”**. Cesare mi guardò meravigliato per la mia intelligenza, si chinò sul calamaio, soffiò … e si ritrasse di scatto con il viso ed il collo grondanti inchiostro, urlando “Signora maestra … Dabroi …”.
Anche dalla maestra Gastaldi che era una vera insegnante e che ricordo con affetto e stima, a volte le prendevo ma a paragone di quelle di Giumìn erano carezze.
* C’è una mosca nel calamaio, toglila che ho paura”.
** E soffiaci no!”
Quei vecchi cari, scomodi banchi delle elementari avevano un unico calamaio centrale costituito da un boccettino di inchiostro bloccato in un foro del banco e nel quale, attraverso lo stretto collo, si intingeva il pennino per scrivere.
Un mattino, senza farmene accorgere, presi una mosca e la buttai nel calamaio, poi tutto agitato dissi a Cesare: “U ghè ina musca in tu caamò; levila che mi a l’ho puia”*
Lui si mise a trafficare con la penna ma essendo il collo del calamaio più stretto del contenitore non riusciva a toglierla così gli suggerii ancora: “E sciuscighe nà”**. Cesare mi guardò meravigliato per la mia intelligenza, si chinò sul calamaio, soffiò … e si ritrasse di scatto con il viso ed il collo grondanti inchiostro, urlando “Signora maestra … Dabroi …”.
Anche dalla maestra Gastaldi che era una vera insegnante e che ricordo con affetto e stima, a volte le prendevo ma a paragone di quelle di Giumìn erano carezze.
* C’è una mosca nel calamaio, toglila che ho paura”.
** E soffiaci no!”
Andora anni 40.
Varo della Motonave Andrianna.
A sinistra, accosciato, Giumìn.
Varo della Motonave Andrianna.
A sinistra, accosciato, Giumìn.
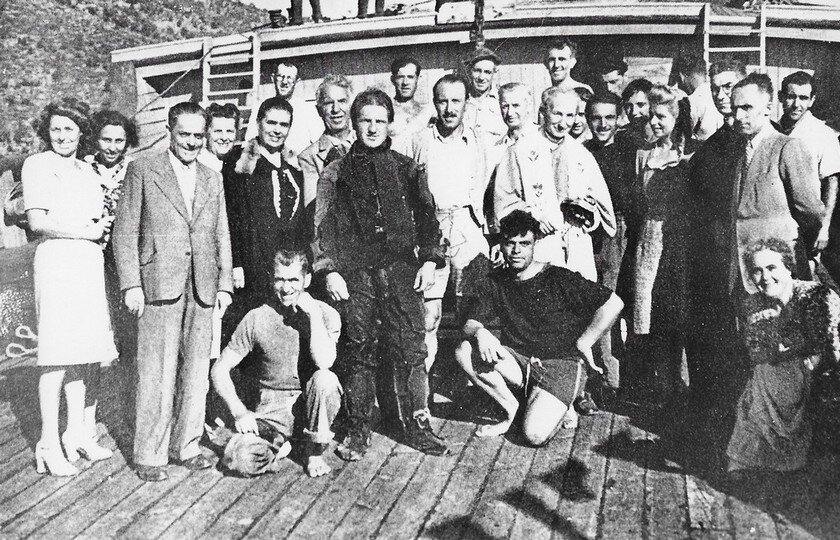
Baciccia viveva con Maria e siccome non erano sposati in chiesa, a Rollo era scoppiato un grosso scandalo che io credevo fosse una specie di sandalo come quelli che portava Giumìn, perciò guardavo sempre i piedi di Baciccia per vedere come era fatto ma non l’ho mai visto.
Baciccia oltre che gli scandali ai piedi portava due spesse pieghe al collo simili ai bargigli di un gallo, che però non cantava mai neanche in chiesa.
Baciccia abitava a Ca’ Tiaferi sopra la casa di Bacicìn de Lasagna ed era proprietario di un uliveto con un rudere che è l’attuale casa Prinz, vicino a Ca’ Bernei, in una località chiamata “a Valle” in cui si recava da ottobre a marzo a raccogliere le olive.
In quel periodo portavo spesso Gialì a pascolare in “a Valle” perché Baciccia aveva sempre con sé un fiasco di vino “cancarùn”*, un pacchetto di carta violacea con un pizzico di zucchero ed alcuni pezzi di pane secco del giorno prima.
I miei primi dolci sono stati i pezzi di pane secco intinti nel vino e zucchero in un bicchiere di Baciccia, nel freddo vento invernale sotto gli ulivi in “a Valle”.
Caro vecchio Baciccia, ovunque tu sia adesso, io credo che non ti manchi pane vino e zucchero!
* Vitigno e vino tipico della zona.
Baciccia oltre che gli scandali ai piedi portava due spesse pieghe al collo simili ai bargigli di un gallo, che però non cantava mai neanche in chiesa.
Baciccia abitava a Ca’ Tiaferi sopra la casa di Bacicìn de Lasagna ed era proprietario di un uliveto con un rudere che è l’attuale casa Prinz, vicino a Ca’ Bernei, in una località chiamata “a Valle” in cui si recava da ottobre a marzo a raccogliere le olive.
In quel periodo portavo spesso Gialì a pascolare in “a Valle” perché Baciccia aveva sempre con sé un fiasco di vino “cancarùn”*, un pacchetto di carta violacea con un pizzico di zucchero ed alcuni pezzi di pane secco del giorno prima.
I miei primi dolci sono stati i pezzi di pane secco intinti nel vino e zucchero in un bicchiere di Baciccia, nel freddo vento invernale sotto gli ulivi in “a Valle”.
Caro vecchio Baciccia, ovunque tu sia adesso, io credo che non ti manchi pane vino e zucchero!
* Vitigno e vino tipico della zona.
Una notte Pippo (*), l’aereo notturno, bombardò un convoglio di chiatte tedesche che navigavano sotto costa trasportando materiale bellico.
Il mattino dopo con Adriano andammo ad ispezionare le scogliere di capo Cervo, dove galleggiavano ed erano arenati tra gli scogli decine di giubbotti salvagente imbottiti di una fibra leggerissima chiamata Kapò e che, portata a casa, Pinuccia trasformò in morbidi cuscini da letto che usammo per anni.
Pochi mesi dopo, alla stazione ferroviaria di Andora, si fermò un treno composto da una decina di vagoni del tipo trasporto merci, chiusi con lucchetti, e rimase sul binario morto, incustodito, per alcuni giorni sinchè qualcuno con un tranciaferro fece saltare i lucchetti.
In meno di un’ora tutto il paese sapeva che il treno era pieno di balle di stoffa di due tipi: uno era tela leggera verde scuro, l’altro era un panno bruno dorato pesante e peloso da un lato.
Io arrivai tardi da Rollo comunque, aiutato da un certo Tabò, riuscii prima a nascondere sotto il tombino di Trevia e poi a portare a casa due rotoli di tela verde e una balla di stoffa pesante.
Per una decina d’anni dormimmo in lenzuola di tela verde e portai giacche e pantaloni di panno bruno.
(*) Non si sapeva chi fosse “Pippo”, se tedesco o alleato, se fosse stato in sola ricognizione o con missione di sganciare bombe.
Probabilmente si trattava di un bimotore inglese o americano (secondo alcune fonti un Mosquito o un bombardiere A20 o B25).
Si sapeva solo che nella notte, misterioso compariva e poteva colpire ovunque, lasciando cadere a caso grappoli di spezzoni incendiari e piccole bombe con delle curiose alette nella parte posteriore, come quelle dei proiettili da mortaio.
Il mattino dopo con Adriano andammo ad ispezionare le scogliere di capo Cervo, dove galleggiavano ed erano arenati tra gli scogli decine di giubbotti salvagente imbottiti di una fibra leggerissima chiamata Kapò e che, portata a casa, Pinuccia trasformò in morbidi cuscini da letto che usammo per anni.
Pochi mesi dopo, alla stazione ferroviaria di Andora, si fermò un treno composto da una decina di vagoni del tipo trasporto merci, chiusi con lucchetti, e rimase sul binario morto, incustodito, per alcuni giorni sinchè qualcuno con un tranciaferro fece saltare i lucchetti.
In meno di un’ora tutto il paese sapeva che il treno era pieno di balle di stoffa di due tipi: uno era tela leggera verde scuro, l’altro era un panno bruno dorato pesante e peloso da un lato.
Io arrivai tardi da Rollo comunque, aiutato da un certo Tabò, riuscii prima a nascondere sotto il tombino di Trevia e poi a portare a casa due rotoli di tela verde e una balla di stoffa pesante.
Per una decina d’anni dormimmo in lenzuola di tela verde e portai giacche e pantaloni di panno bruno.
(*) Non si sapeva chi fosse “Pippo”, se tedesco o alleato, se fosse stato in sola ricognizione o con missione di sganciare bombe.
Probabilmente si trattava di un bimotore inglese o americano (secondo alcune fonti un Mosquito o un bombardiere A20 o B25).
Si sapeva solo che nella notte, misterioso compariva e poteva colpire ovunque, lasciando cadere a caso grappoli di spezzoni incendiari e piccole bombe con delle curiose alette nella parte posteriore, come quelle dei proiettili da mortaio.
Dopo l’incendio della pineta della Concezione i nostri genitori decisero di bruciare e far esplodere tutto il materiale bellico lasciato incustodito dai militari in fuga nella caserma della Colonia dei Poveri.
Naturalmente subito dopo la nostra banda si precipitò a recuperare tutto il possibile.
Tra le altre cose io trovai una bomba a mano del tipo Balilla, della quale ero abbastanza pratico per averne già smontato qualcuna, ma questa era bruciacchiata e mezza fusa sicchè non potevo smontarla per recuperare la catenella che avvolge l’esplosivo.
Togliemmo allora la sicura e lanciammo la bomba riparandoci dietro il muretto della ferrovia.
La bomba rimbalzò alcune volte senza esplodere e si fermò nel piazzale; uno dei più coraggiosi andò a prenderla e la lanciò mentre gli altri stavano a guardare: ancora la bomba rimbalzò, rotolò, e si fermò senza esplodere.
La scena si ripetè diverse volte sino a quando uno lanciava e gli altri partivano di corsa per arrivare i primi ad afferrarla e rilanciarla.
Ad un certo punto Adriano lanciò ed io scattai per primo ma Giuvanni du Bagnau mi superò e quando stava per raggiungerla la bomba scoppiò in una nuvola di terra e di fumo crivellandolo di schegge, una delle quali gli si conficcò in una guancia a pochi centimetri dall’occhio.
Ancora oggi, a quasi settant’anni, porta la cicatrice nerastra sotto l’occhio.
Non so se lui le abbia prese, ma a me ne dettero tante che avrei voluto essere al suo posto in ospedale.
Naturalmente subito dopo la nostra banda si precipitò a recuperare tutto il possibile.
Tra le altre cose io trovai una bomba a mano del tipo Balilla, della quale ero abbastanza pratico per averne già smontato qualcuna, ma questa era bruciacchiata e mezza fusa sicchè non potevo smontarla per recuperare la catenella che avvolge l’esplosivo.
Togliemmo allora la sicura e lanciammo la bomba riparandoci dietro il muretto della ferrovia.
La bomba rimbalzò alcune volte senza esplodere e si fermò nel piazzale; uno dei più coraggiosi andò a prenderla e la lanciò mentre gli altri stavano a guardare: ancora la bomba rimbalzò, rotolò, e si fermò senza esplodere.
La scena si ripetè diverse volte sino a quando uno lanciava e gli altri partivano di corsa per arrivare i primi ad afferrarla e rilanciarla.
Ad un certo punto Adriano lanciò ed io scattai per primo ma Giuvanni du Bagnau mi superò e quando stava per raggiungerla la bomba scoppiò in una nuvola di terra e di fumo crivellandolo di schegge, una delle quali gli si conficcò in una guancia a pochi centimetri dall’occhio.
Ancora oggi, a quasi settant’anni, porta la cicatrice nerastra sotto l’occhio.
Non so se lui le abbia prese, ma a me ne dettero tante che avrei voluto essere al suo posto in ospedale.
Gli uliveti liguri, nel corso dei secoli, avevano subito decine di frazionamenti tra eredi, praticamente ad ogni generazione; ciò aveva portato ad uno spezzettamento delle proprietà in micromappali alcuni all’assurdo di un unico albero di ulivo su di una proprietà inferiore ai dieci metri quadrati.
Questa situazione rendeva irrazionale ed antieconomica la coltivazione dato che un proprietario di diciamo diecimila metri di uliveti doveva spostarsi su dieci, quindici, a volte trenta “scìti”* diversi a volte a notevole distanza tra loro.
Un aspetto poco conosciuto di questo stato di cose si verificava, quando, ed era così nella maggior parte dei casi, il confine correva lungo un muro di fascia.
Succedeva allora che la chioma degli alberi della proprietà superiore sporgesse di alcuni metri sulla proprietà inferiore coprendo od intrecciandosi con i rami delle piante sottostanti, generando confusione sulla appartenenza all’uno od all’altro proprietario del frutto caduto a terra.
Interveniva allora l’esperto detto “Stimaù”** che tracciava sul terreno, ammucchiando terra foglie e sassi, una linea detta “cunfina”*** che seguiva approssimativamente la verticale della chioma dell’albero soprastante o la mediana dell’intreccio dei rami, definendo così gli spazi di raccolta tra i proprietari.
Tale sistema non fu contestato per secoli sino a quando, per tutto un inverno a Rollo non sorsero discussioni sull’operato dello “stimaù” che chiaramente aveva sbagliato il tracciamento delle cunfine in molti uliveti.
Le discussioni e le liti tra proprietari confinanti continuarono sino a quando Petalìn che era un tipo irascibile e che bestemmiava come un turco, mi scoperse a spostare le cunfine sotto un suo uliveto.
Oltre alle solite legnate da Petalìn e da Giumìn, ricevetti anche il divieto di pascolo per Gialì negli uliveti per tutto il periodo di raccolta delle olive.
* appezzamenti o mappali.
** stimatore.
*** limite di raccolta.
Questa situazione rendeva irrazionale ed antieconomica la coltivazione dato che un proprietario di diciamo diecimila metri di uliveti doveva spostarsi su dieci, quindici, a volte trenta “scìti”* diversi a volte a notevole distanza tra loro.
Un aspetto poco conosciuto di questo stato di cose si verificava, quando, ed era così nella maggior parte dei casi, il confine correva lungo un muro di fascia.
Succedeva allora che la chioma degli alberi della proprietà superiore sporgesse di alcuni metri sulla proprietà inferiore coprendo od intrecciandosi con i rami delle piante sottostanti, generando confusione sulla appartenenza all’uno od all’altro proprietario del frutto caduto a terra.
Interveniva allora l’esperto detto “Stimaù”** che tracciava sul terreno, ammucchiando terra foglie e sassi, una linea detta “cunfina”*** che seguiva approssimativamente la verticale della chioma dell’albero soprastante o la mediana dell’intreccio dei rami, definendo così gli spazi di raccolta tra i proprietari.
Tale sistema non fu contestato per secoli sino a quando, per tutto un inverno a Rollo non sorsero discussioni sull’operato dello “stimaù” che chiaramente aveva sbagliato il tracciamento delle cunfine in molti uliveti.
Le discussioni e le liti tra proprietari confinanti continuarono sino a quando Petalìn che era un tipo irascibile e che bestemmiava come un turco, mi scoperse a spostare le cunfine sotto un suo uliveto.
Oltre alle solite legnate da Petalìn e da Giumìn, ricevetti anche il divieto di pascolo per Gialì negli uliveti per tutto il periodo di raccolta delle olive.
* appezzamenti o mappali.
** stimatore.
*** limite di raccolta.
Fiuìna, di famiglia benestante, era la madre di Battistìn detto di Fiuìna per distinguerlo dall’altro Battistìn “u bancaò” che faceva il falegname ed abitava a Cae Suttae.
Fiuìna abitava nella casa di fronte alla chiesa; quando tornavo da scuola alle elementari ad Andora, specie nei periodi caldi, mi fermavo e le chiedevo una “cassa d’òigua” cioè un mestolo d’acqua dal secchio tenuto al fresco e lei diceva sempre: “Ahi mi meschina, Segnù piòime”* ma poi andava in cucina e sbatteva due rossi d’uovo con due cucchiai di zucchero aggiungendovi poi mezzo bicchiere di marsala e se li beveva alla salute.
Battistìn de Fiuìna faceva il sacrestano ed era quasi completamente cieco per la sifilide contratta in Argentina quando da giovane faceva il marinaio.
Io credevo che la sifilide fosse una formica cattiva perché in casa avevamo le formiche che anche loro erano argentine, mentre i “cagnìn” erano formiche più grosse, nere, che vivevano nei tronchi degli alberi.
Battistìn de Fiuìna mi voleva bene perché facevo il chierichetto e un giorno che ero rimasto con il braccio bloccato in un buco del muro del campanile al piano dell’orologio, per prendere un nido di passeri, dopo aver gridato tutto il pomeriggio, mi liberò allargando il buco con punta e mazzetta, avendomi sentito quando era venuto a suonare l’Ave Maria delle sei.
Avevo il braccio nero e tumefatto ma Giumìn me le suonò lo stesso perché non avevo innaffiato l’orto.
Battistìn de Fiuìna mi aiutava sempre quando ne combinavo qualcuna come quando spogliai completamente l’albero di giuggiole di Ninìn. Quando andammo ad abitare ad Alassio Battistìn de Fiuìna mi regalò una tabacchierta d’argento e non l’ho più rivisto.
* “Ah poveretta me, Signore prendetemi!”
Fiuìna abitava nella casa di fronte alla chiesa; quando tornavo da scuola alle elementari ad Andora, specie nei periodi caldi, mi fermavo e le chiedevo una “cassa d’òigua” cioè un mestolo d’acqua dal secchio tenuto al fresco e lei diceva sempre: “Ahi mi meschina, Segnù piòime”* ma poi andava in cucina e sbatteva due rossi d’uovo con due cucchiai di zucchero aggiungendovi poi mezzo bicchiere di marsala e se li beveva alla salute.
Battistìn de Fiuìna faceva il sacrestano ed era quasi completamente cieco per la sifilide contratta in Argentina quando da giovane faceva il marinaio.
Io credevo che la sifilide fosse una formica cattiva perché in casa avevamo le formiche che anche loro erano argentine, mentre i “cagnìn” erano formiche più grosse, nere, che vivevano nei tronchi degli alberi.
Battistìn de Fiuìna mi voleva bene perché facevo il chierichetto e un giorno che ero rimasto con il braccio bloccato in un buco del muro del campanile al piano dell’orologio, per prendere un nido di passeri, dopo aver gridato tutto il pomeriggio, mi liberò allargando il buco con punta e mazzetta, avendomi sentito quando era venuto a suonare l’Ave Maria delle sei.
Avevo il braccio nero e tumefatto ma Giumìn me le suonò lo stesso perché non avevo innaffiato l’orto.
Battistìn de Fiuìna mi aiutava sempre quando ne combinavo qualcuna come quando spogliai completamente l’albero di giuggiole di Ninìn. Quando andammo ad abitare ad Alassio Battistìn de Fiuìna mi regalò una tabacchierta d’argento e non l’ho più rivisto.
* “Ah poveretta me, Signore prendetemi!”
Chiesa della SS. Trinità.
Il foro a sinistra dell’orologio è per me un vivo ricordo.
Il foro a sinistra dell’orologio è per me un vivo ricordo.

A Rollo, in quegli anni, non si era mai sentito parlare di avvocati, studi legali, cause e querele.
A risolvere la maggior parte delle controversie che, inevitabilmente, sorgevano tra le famiglie bastava l’unica cosa che in paese abbondava: il buonsenso.
Quando proprio la questione superava i limiti, interveniva l’esperienza e la saggezza, a volte l’autorità, degli anziani che spesso con ironia feroce ricorrevano ai “diti”:
“Cuu tempu e cua pàia, anche i nèspui maüa”. Col tempo e con la paglia anche le nespole maturano, cioè anche le situazioni più aspre e difficili col tempo e senza irritarle si ammorbidiscono.
“U ghe n’è pe’ l’ose e pe’ chi u mena”. C’è n’è per l’asino e per chi lo conduce: quando sorgeva una divergenza in cui torto e ragione non erano ben definiti.
“E reloiu u se ferma, ma u tempo na”. L’orologio si può fermare ma non il tempo, a proposito di giovanotti e signorine stagionati che … truccavano l’età.
“Chi fa u passu ciü longu da gamba prima o pöi u se ingamba”. Chi fa il passo più lungo della gamba prima o dopo inciampa, quando qualcuno concludeva malamente un affare al di sopra delle sue possibilità o un lavoro che superava le sue capacità.
“U fa ciü burdèllu in erbuu cu cazze che in boscu cu cresce”. Fa più rumore un albero che cade di un bosco che cresce, a proposito di un fatto increscioso o di uno scandalo scoppiato in un ambiente perbene e che aveva fatto notizia.
“I sun Messe dite e Vespri cantài”. Vale a dire Messe dette e Vespri cantati a proposito di attività lavorative o sessuali di persone avanti con gli anni ma ancora velleitarie.
“Palanche i fan palanche e pigöggi i fan pigöggi” che non ha bisogno di traduzione.
“Cölli de Rollu pe’ ina figa i se rumpe u collu” e mai proverbio fu più azzecccato che nel mio caso, quando rimasi infilzato per una spalla su di un cancelletto della proprietà Bigoni di fronte al pozzo di Cae Suttae, essendosi squarciato il ramo sul quale ero salito per rubare i fichi maturi.
“A l’è ina scicutea”. Dal latino “Sicut erat in principio ed nunc et semper …” di cosa che si ripete monotonamente sempre uguale.
Ed innumerevoli altri adatti ad ogni circostanza.
Comunque l’esperienza, il buonsenso, l’ironia ed il tempo sostituivano abbondantemente codici e leggi che la gente non sapeva neppure che esistessero.
* letteralmente: detti o proverbi o massime.
A risolvere la maggior parte delle controversie che, inevitabilmente, sorgevano tra le famiglie bastava l’unica cosa che in paese abbondava: il buonsenso.
Quando proprio la questione superava i limiti, interveniva l’esperienza e la saggezza, a volte l’autorità, degli anziani che spesso con ironia feroce ricorrevano ai “diti”:
“Cuu tempu e cua pàia, anche i nèspui maüa”. Col tempo e con la paglia anche le nespole maturano, cioè anche le situazioni più aspre e difficili col tempo e senza irritarle si ammorbidiscono.
“U ghe n’è pe’ l’ose e pe’ chi u mena”. C’è n’è per l’asino e per chi lo conduce: quando sorgeva una divergenza in cui torto e ragione non erano ben definiti.
“E reloiu u se ferma, ma u tempo na”. L’orologio si può fermare ma non il tempo, a proposito di giovanotti e signorine stagionati che … truccavano l’età.
“Chi fa u passu ciü longu da gamba prima o pöi u se ingamba”. Chi fa il passo più lungo della gamba prima o dopo inciampa, quando qualcuno concludeva malamente un affare al di sopra delle sue possibilità o un lavoro che superava le sue capacità.
“U fa ciü burdèllu in erbuu cu cazze che in boscu cu cresce”. Fa più rumore un albero che cade di un bosco che cresce, a proposito di un fatto increscioso o di uno scandalo scoppiato in un ambiente perbene e che aveva fatto notizia.
“I sun Messe dite e Vespri cantài”. Vale a dire Messe dette e Vespri cantati a proposito di attività lavorative o sessuali di persone avanti con gli anni ma ancora velleitarie.
“Palanche i fan palanche e pigöggi i fan pigöggi” che non ha bisogno di traduzione.
“Cölli de Rollu pe’ ina figa i se rumpe u collu” e mai proverbio fu più azzecccato che nel mio caso, quando rimasi infilzato per una spalla su di un cancelletto della proprietà Bigoni di fronte al pozzo di Cae Suttae, essendosi squarciato il ramo sul quale ero salito per rubare i fichi maturi.
“A l’è ina scicutea”. Dal latino “Sicut erat in principio ed nunc et semper …” di cosa che si ripete monotonamente sempre uguale.
Ed innumerevoli altri adatti ad ogni circostanza.
Comunque l’esperienza, il buonsenso, l’ironia ed il tempo sostituivano abbondantemente codici e leggi che la gente non sapeva neppure che esistessero.
* letteralmente: detti o proverbi o massime.
Un pomeriggio Giumìn mi diede cinquanta centesimi e mi disse di andare dal barbiere a farmi tagliare i capelli mentre lui e Pinuccia lavoravano in un uliveto detto “sgaiàu”* sotto Rollo ove oggi sorge il villaggio Aurora.
Io andai dal barbiere Casulla, sulla vecchia Aurelia, mi feci tagliare i capelli e poi gli dissi che sarebbe passato mio padre a pagare.
Mi recai poi al negozio della “Culétta” del quale ricordo ancora l’odore particolare perché vi si vendeva di tutto: dai vari tipi di pasta nei cassetti di un mobile a parete, alle casse di carrube per le mule, alle caramelle, alla frutta, alla verdura, alle casseruole in terracotta, ai secchi smaltati, alle fave, ceci e piselli secchi, crusca, castagne, biscotti all’anice, liquirizia, stoccafisso e baccalà in una bacinella d’acqua, e decine di altri prodotti compresi i formaggi in una vetrina di rete metallica per le mosche.
Comunque con i cinquanta centesimi comprai una montagna di confetti, di mentine colorate, di liquirizia e bastoncini di zucchero filato.
Sfortuna volle che Giumìn, avendo bisogno di una corda, venisse ad Andora a comprarla nel negozio di “Culétta” e passasse dal bar Torrengo davanti al barbiere.
Quel giorno collaudai ed ammmorbidii personalmente la corda di Giumìn perché feci il percorso dal passaggio a livello sino allo “sgaiàu” a cordate nelle gambe.
* Sprecato.
Io andai dal barbiere Casulla, sulla vecchia Aurelia, mi feci tagliare i capelli e poi gli dissi che sarebbe passato mio padre a pagare.
Mi recai poi al negozio della “Culétta” del quale ricordo ancora l’odore particolare perché vi si vendeva di tutto: dai vari tipi di pasta nei cassetti di un mobile a parete, alle casse di carrube per le mule, alle caramelle, alla frutta, alla verdura, alle casseruole in terracotta, ai secchi smaltati, alle fave, ceci e piselli secchi, crusca, castagne, biscotti all’anice, liquirizia, stoccafisso e baccalà in una bacinella d’acqua, e decine di altri prodotti compresi i formaggi in una vetrina di rete metallica per le mosche.
Comunque con i cinquanta centesimi comprai una montagna di confetti, di mentine colorate, di liquirizia e bastoncini di zucchero filato.
Sfortuna volle che Giumìn, avendo bisogno di una corda, venisse ad Andora a comprarla nel negozio di “Culétta” e passasse dal bar Torrengo davanti al barbiere.
Quel giorno collaudai ed ammmorbidii personalmente la corda di Giumìn perché feci il percorso dal passaggio a livello sino allo “sgaiàu” a cordate nelle gambe.
* Sprecato.
Andora 1938.
A destra, in giacca bianca, il barbiere Casulla.
A destra, in giacca bianca, il barbiere Casulla.

Solitamente da marzo ad ottobre, eccetto che per andare a messa ed a scuola, si andava in giro scalzi; ricordo che Adriano ed io andavamo da Rollo allo “scoglio a picco” sotto l’attuale villaggio Conca Verde saltando da una fascia all’altra senza seguire né strade né sentieri perché avevamo la pelle della pianta dei piedi spessa proprio come la suola di una scarpa.
Quando, raramente, uno stecco riusciva a bucarla lo toglievamo, facevamo pipì sulla ferita per disinfettarla e via di nuovo senza far caso al dolore.
Molto più dolorose le “süppàe” quando, a seguito di un calcio dato inavvertitamente ad un sasso sporgente ed infisso nel terreno, si apriva una ferita di solito al pollice lungo tutto il margine dell’unghia.
Però d’inverno, specie quando pioveva, bisognava mettere le scarpe e siccome io oltre ad avere una naturale predisposizione per sfasciarle dovevo percorrere sia le mulattiere da Ca’ Bernei ad Andora per andare a scuola, sia i sentieri acciottolati per andare a pascolare Gialì, consumavo le scarpe come fossero state di carta velina.
Giumìn allora prese provvedimenti: un mattino all’alba partimmo a piedi ed andammo a Tovo, dopo Chiappa, passando per la Colla, da un calzolaio detto “U Caegò” che mi prese le misure per un paio di scarponi che Giumìn volle di quattro numeri più grandi e con la suola fitta di “bruchette” che erano chiodi a testa larga e zigrinata che sporgevano sotto la suola; volle anche che sulla suola, al tacco e alla punta, u caegò mettesse le mezzelune in ferro.
Dopo un mese andammo a ritirare il capolavoro; Giumìn riempì le punte degli scarponi con carta bagnata, strizzata e pigiata finchè si adattarono al mio piede e mi ordinò di ungerle con la “sciùnza” che era grasso puzzolente, tutte le settimane, cosa che feci per i tre o quattro anni seguenti, togliendo ogni anno un centimetro di carta dalla punta.
Quando, raramente, uno stecco riusciva a bucarla lo toglievamo, facevamo pipì sulla ferita per disinfettarla e via di nuovo senza far caso al dolore.
Molto più dolorose le “süppàe” quando, a seguito di un calcio dato inavvertitamente ad un sasso sporgente ed infisso nel terreno, si apriva una ferita di solito al pollice lungo tutto il margine dell’unghia.
Però d’inverno, specie quando pioveva, bisognava mettere le scarpe e siccome io oltre ad avere una naturale predisposizione per sfasciarle dovevo percorrere sia le mulattiere da Ca’ Bernei ad Andora per andare a scuola, sia i sentieri acciottolati per andare a pascolare Gialì, consumavo le scarpe come fossero state di carta velina.
Giumìn allora prese provvedimenti: un mattino all’alba partimmo a piedi ed andammo a Tovo, dopo Chiappa, passando per la Colla, da un calzolaio detto “U Caegò” che mi prese le misure per un paio di scarponi che Giumìn volle di quattro numeri più grandi e con la suola fitta di “bruchette” che erano chiodi a testa larga e zigrinata che sporgevano sotto la suola; volle anche che sulla suola, al tacco e alla punta, u caegò mettesse le mezzelune in ferro.
Dopo un mese andammo a ritirare il capolavoro; Giumìn riempì le punte degli scarponi con carta bagnata, strizzata e pigiata finchè si adattarono al mio piede e mi ordinò di ungerle con la “sciùnza” che era grasso puzzolente, tutte le settimane, cosa che feci per i tre o quattro anni seguenti, togliendo ogni anno un centimetro di carta dalla punta.
Petalìn era un ometto minuto quasi calvo e baffuto e un po’ isterico che, oltre a lavorare nei suoi terreni andava a potare a giornata o, come si diceva, a “brundiò” negli uliveti di altri proprietari.
Dopo aver concordato data, luogo e prezzo del lavoro, il giorno stabilito partiva all’alba portandosi scala, piccozzino, gancio, saracco, corda, forbici da potare e quanto altro.
Giunto sul posto compiva una prima ispezione per scegliere l’albero dal quale iniziare, tenendo conto del sole, del vento ecc.
Scelto l’albero trasportava tutta l’attrezzatura alla “causa”* appoggiava la scala, saliva e, giunto in cima “Porcu de lì … porcu de là … a me sun scurdàu e tesùie”.
Scendeva, prendeva le forbici, risaliva e “Porcu de lì … porcu de là … a me sun scurdàu u gànciu”.
Scendeva, prendeva il gancio, risaliva e ricominciava la litania con accompagnamento di petti che, se si era sottovento, si avvertivano dalla costa opposta a cinquecento metri.
A mezzogiorno, finito sì e no il primo albero, andava a casa.
Il giorno dopo riprendeva la “scicutéa”**.
Petalìn al pomeriggio andava a lavorare nei suoi uliveti e siccome era ossessionato dal timore che gli avvelenassero la verdura, si era fatto l’orticello al “fussàu de razze” lontano da Rollo sopra l’attuale viadotto autostradale del Rinovo ove esiste ancora una minuscola sorgente.
Un giorno Adriano ed io gli piantammo nell’orto due paletti con i cartelli di “ATTENZIONE VERDURE AVVELENATE” e mettemmo due boccettini coll’etichetta col teschio vicino alla pozza della sorgente.
Dopo qualche giorno facemmo un controllo: Petalìn aveva sradicato tutto l’orto e tagliato tutti gli alberi d’ulivo.
La pozza della sorgente era sparita ed al suo posto una enorme buca impediva l’accesso al terreno.
* Base del tronco, ceppo.
** Cosa che si ripete; vedi capitolo “I Diti”
Dopo aver concordato data, luogo e prezzo del lavoro, il giorno stabilito partiva all’alba portandosi scala, piccozzino, gancio, saracco, corda, forbici da potare e quanto altro.
Giunto sul posto compiva una prima ispezione per scegliere l’albero dal quale iniziare, tenendo conto del sole, del vento ecc.
Scelto l’albero trasportava tutta l’attrezzatura alla “causa”* appoggiava la scala, saliva e, giunto in cima “Porcu de lì … porcu de là … a me sun scurdàu e tesùie”.
Scendeva, prendeva le forbici, risaliva e “Porcu de lì … porcu de là … a me sun scurdàu u gànciu”.
Scendeva, prendeva il gancio, risaliva e ricominciava la litania con accompagnamento di petti che, se si era sottovento, si avvertivano dalla costa opposta a cinquecento metri.
A mezzogiorno, finito sì e no il primo albero, andava a casa.
Il giorno dopo riprendeva la “scicutéa”**.
Petalìn al pomeriggio andava a lavorare nei suoi uliveti e siccome era ossessionato dal timore che gli avvelenassero la verdura, si era fatto l’orticello al “fussàu de razze” lontano da Rollo sopra l’attuale viadotto autostradale del Rinovo ove esiste ancora una minuscola sorgente.
Un giorno Adriano ed io gli piantammo nell’orto due paletti con i cartelli di “ATTENZIONE VERDURE AVVELENATE” e mettemmo due boccettini coll’etichetta col teschio vicino alla pozza della sorgente.
Dopo qualche giorno facemmo un controllo: Petalìn aveva sradicato tutto l’orto e tagliato tutti gli alberi d’ulivo.
La pozza della sorgente era sparita ed al suo posto una enorme buca impediva l’accesso al terreno.
* Base del tronco, ceppo.
** Cosa che si ripete; vedi capitolo “I Diti”
U Noru era il proprietario di un ristorante per camionisti sull’Aurelia ed era famoso per gli uccelletti in casseruola che catturava a migliaia con il vischio e le gabbie da richiamo sulle piante di “verne” del torrente Merula, allora non arginato e nostro territorio di esplorazione.
Era anche il proprietario di un terreno vicino all’attuale ponte “Italia 61” terreno sul quale si ergeva un superbo ciliegio dal tronco liscio di oltre cinque metri di altezza.
Per una intera primavera Adriano, Giuvanni du Bagnau ed io gli fregammo le ciliegie approfittando di una scala in legno che il Noru lasciava all’interno di una baracca, ma la primavera successiva, accortosi del fatto, fece sparire la scala sicchè, data l’altezza e la conformazione del tronco che non offriva appigli, non riuscivamo a raggiungere le ciliegie.
Un pomeriggio, dopo il bagno, ci eravamo radunati ad ammirare quei duroni quasi neri quando Giuvanni du Bagnau, che abitava poco distante ebbe un’idea: andò a casa e ritornò con un piccozzino affilato.
Dopo dieci minuti il grande tronco giaceva sul terreno e noi ci riempivamo tasche e stomaco di ciliegie. Osso e tutto.
Il Noru denunciò il fatto ed il carabiniere della stazione fece il giro delle famiglie denunciate.
Quello che seguì fu veramente indimenticabile: Pinuccia mi portò dal medico Caviglia che mi diede cinque punti di sutura alla nuca oltre a prescrivermi impiastri di semi di lino sui vari ematomi.
Comunque nel corso di quell’estate rubammo al Noru una dozzina di “scindrie” dette angurie in italiano. Adriano si sbagliò e, nella fretta e nel buio, rubò due zucche.
Era anche il proprietario di un terreno vicino all’attuale ponte “Italia 61” terreno sul quale si ergeva un superbo ciliegio dal tronco liscio di oltre cinque metri di altezza.
Per una intera primavera Adriano, Giuvanni du Bagnau ed io gli fregammo le ciliegie approfittando di una scala in legno che il Noru lasciava all’interno di una baracca, ma la primavera successiva, accortosi del fatto, fece sparire la scala sicchè, data l’altezza e la conformazione del tronco che non offriva appigli, non riuscivamo a raggiungere le ciliegie.
Un pomeriggio, dopo il bagno, ci eravamo radunati ad ammirare quei duroni quasi neri quando Giuvanni du Bagnau, che abitava poco distante ebbe un’idea: andò a casa e ritornò con un piccozzino affilato.
Dopo dieci minuti il grande tronco giaceva sul terreno e noi ci riempivamo tasche e stomaco di ciliegie. Osso e tutto.
Il Noru denunciò il fatto ed il carabiniere della stazione fece il giro delle famiglie denunciate.
Quello che seguì fu veramente indimenticabile: Pinuccia mi portò dal medico Caviglia che mi diede cinque punti di sutura alla nuca oltre a prescrivermi impiastri di semi di lino sui vari ematomi.
Comunque nel corso di quell’estate rubammo al Noru una dozzina di “scindrie” dette angurie in italiano. Adriano si sbagliò e, nella fretta e nel buio, rubò due zucche.
La domenica mattina a Rollo si suonavano le campane per avvisare gli abitanti che stava per iniziare la Messa.
Battistìn de Fiuìna il sacrestano suonava, e mi aveva insegnato a suonare “a prima, a segunda, a terza, u ciucchìn e u rabaiùn”*
Soltanto nelle feste grandi quando i preti dicevano la Messa in terza intervenivano i vecchi a “battaiò” cioè a suonare a mano senza le corde, impugnando i batacchi.
Quando suonava il ciucchìn dalle varie borgate ancora abitate cioè da Ca’ Bernei, da Bande de Là, Ca’ Tiaferi e Cae Suttae, cominciava ad arrivare gente vestita a festa il che voleva dire pantaloni di fustagno e faudài di panno, gilè e giachè un po’ meno rammendati dei soliti usati per il lavoro.
U Tibì abitava a Bande de Là di fianco a Chicòttu ed era un vecchio dal portamento dignitoso che io avevo individuato come un discendente del Corsaro Nero, perché aveva una fluente barba bianca ed era completamente vestito di nero compreso il cappello di feltro.
U Tibì usciva di casa vestito di tutto punto e scalzo, con in mano un paio di vecchie scarpe nere spazzolate a specchio; percorreva i cinque o seicento metri sino al sagrato della chiesa sempre scalzo e con i pantaloni rimboccati; arrivato alla porta si metteva le scarpe, annodava le stringhe, disimboccava i pantaloni, entrava in chiesa, assisteva alla messa, usciva, ripeteva il tutto in senso inverso e andava a casa.
Le vecchie di Rollo, tra una presa di tabacco e l’altra, sostenevano che le scarpe in questione fossero quelle del padre che era stato sepolto scalzo.
Probabilmente, alla sua morte, il Tibì non avendo eredi avrà compiuto l’ultima trasferta con le scarpe ai piedi.
* Intraducibili: il ciucchìn era il suono della campana piccola, il rabaiùn quello della campana più grossa.
Battistìn de Fiuìna il sacrestano suonava, e mi aveva insegnato a suonare “a prima, a segunda, a terza, u ciucchìn e u rabaiùn”*
Soltanto nelle feste grandi quando i preti dicevano la Messa in terza intervenivano i vecchi a “battaiò” cioè a suonare a mano senza le corde, impugnando i batacchi.
Quando suonava il ciucchìn dalle varie borgate ancora abitate cioè da Ca’ Bernei, da Bande de Là, Ca’ Tiaferi e Cae Suttae, cominciava ad arrivare gente vestita a festa il che voleva dire pantaloni di fustagno e faudài di panno, gilè e giachè un po’ meno rammendati dei soliti usati per il lavoro.
U Tibì abitava a Bande de Là di fianco a Chicòttu ed era un vecchio dal portamento dignitoso che io avevo individuato come un discendente del Corsaro Nero, perché aveva una fluente barba bianca ed era completamente vestito di nero compreso il cappello di feltro.
U Tibì usciva di casa vestito di tutto punto e scalzo, con in mano un paio di vecchie scarpe nere spazzolate a specchio; percorreva i cinque o seicento metri sino al sagrato della chiesa sempre scalzo e con i pantaloni rimboccati; arrivato alla porta si metteva le scarpe, annodava le stringhe, disimboccava i pantaloni, entrava in chiesa, assisteva alla messa, usciva, ripeteva il tutto in senso inverso e andava a casa.
Le vecchie di Rollo, tra una presa di tabacco e l’altra, sostenevano che le scarpe in questione fossero quelle del padre che era stato sepolto scalzo.
Probabilmente, alla sua morte, il Tibì non avendo eredi avrà compiuto l’ultima trasferta con le scarpe ai piedi.
* Intraducibili: il ciucchìn era il suono della campana piccola, il rabaiùn quello della campana più grossa.
Bande de Là – In basso la casa del Tibì.
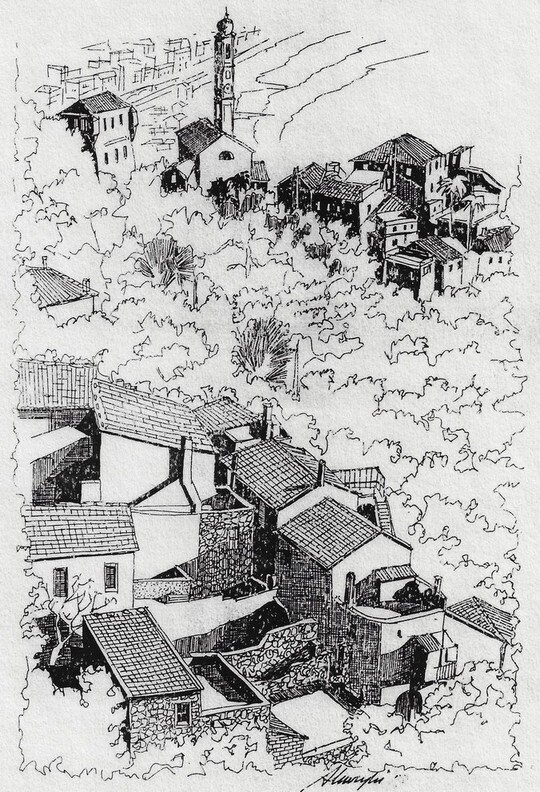
Nel quarantatrè Giumìn faceva un po’ di “borsa nera” che consisteva nel contrabbando di generi alimentari, allora razionati, per rimediare qualcosa da mangiare, portando olio e sale in Piemonte e scambiandolo con polenta, farina e lardo.
A quell’epoca avevo dieci anni e Pinuccia si era procurata una lattina da sedici litri ed aveva cucito uno zainetto per trasportarla più comodamente.
Al pomeriggio partivo con il mio zainetto, salivo alla Colla, andavo a Chiappa e scendevo al “Muìn du figu” nella valle di San Bartolomeo del Cervo dove era in funzione un vecchio frantoio che lavorava di nascosto dalle autorità.
Lì mi riempivano la lattina d’olio, pagavo e ritornavo a Rollo dove Giumìn versava l’olio in una giara da ottanta litri e poi una volta piena con dei grossi contenitori in lamiera detti “lame” lo portava in Piemonte col treno a carbone.
Dovevo però stare attento che il “gumbaiö”* non mi desse olio “lavato” cioè ricavato dalla sansa la pasta di olive, nocciolo e pelle ormai spremuta e lavata in acqua calda.
L’olio lavato veniva a galla nella vasca ed era recuperato con la “lecca” uno strumento in lamiera fatto come un piatto col manico con cui si sfiorava la superficie dell’acqua cogliendo il velo d’olio che galleggiava e che era di qualità inferiore.
Tornando a casa deviavo spesso per le pinete e per la macchia cercando nidi, così che quasi sempre arrivavo a Rollo di notte.
Un pomeriggio capitai su di un nido di “scarùgi”, quei grossi vesponi gialli e neri; cercai di scappare, abbandonando anche lo zaino, ma due mi punsero, così arrivai a casa gonfio come un pallone.
Giumìn mi diede solo qualche calcio nel sedere e si fece accompagnare sul posto.
Fortunatamente ritrovammo zaino e lattina piena ad una decina di metri dal nido, evitando così mio padre di essere punto ed io altre legnate.
* Frantoiano.
A quell’epoca avevo dieci anni e Pinuccia si era procurata una lattina da sedici litri ed aveva cucito uno zainetto per trasportarla più comodamente.
Al pomeriggio partivo con il mio zainetto, salivo alla Colla, andavo a Chiappa e scendevo al “Muìn du figu” nella valle di San Bartolomeo del Cervo dove era in funzione un vecchio frantoio che lavorava di nascosto dalle autorità.
Lì mi riempivano la lattina d’olio, pagavo e ritornavo a Rollo dove Giumìn versava l’olio in una giara da ottanta litri e poi una volta piena con dei grossi contenitori in lamiera detti “lame” lo portava in Piemonte col treno a carbone.
Dovevo però stare attento che il “gumbaiö”* non mi desse olio “lavato” cioè ricavato dalla sansa la pasta di olive, nocciolo e pelle ormai spremuta e lavata in acqua calda.
L’olio lavato veniva a galla nella vasca ed era recuperato con la “lecca” uno strumento in lamiera fatto come un piatto col manico con cui si sfiorava la superficie dell’acqua cogliendo il velo d’olio che galleggiava e che era di qualità inferiore.
Tornando a casa deviavo spesso per le pinete e per la macchia cercando nidi, così che quasi sempre arrivavo a Rollo di notte.
Un pomeriggio capitai su di un nido di “scarùgi”, quei grossi vesponi gialli e neri; cercai di scappare, abbandonando anche lo zaino, ma due mi punsero, così arrivai a casa gonfio come un pallone.
Giumìn mi diede solo qualche calcio nel sedere e si fece accompagnare sul posto.
Fortunatamente ritrovammo zaino e lattina piena ad una decina di metri dal nido, evitando così mio padre di essere punto ed io altre legnate.
* Frantoiano.
Al tempo in cui Giumìn faceva la borsa nera, oltre all’olio bisognava procurarsi il sale e, non esistendo negozi dove comprarlo, dovevamo fabbricarlo.
Fortunatamente avevamo a disposizione un’infinità di materia prima: il mare.
Giumìn, che aveva fatto il marinaio, e gli altri grandi, si erano procurati, probabilmente rubandole nel cantiere navale, alcune grandi lamiere rettangolari; rialzandone a martellate i bordi si ottenevano delle rudimentali vasche piane di quasi due metri quadrati di superficie.
Trasportate in spiaggia poste su treppiedi in ferro sopra un fuoco di sterpi e legna, venivano riempite di acqua di mare.
Con l’ebollizione e l’evaporazione si depositava sul fondo uno strato di sale un po’ amaro ma commestibile; una volta evaporata tutta l’acqua ed asciugato il sale questo veniva raschiato con una spatola di legno, raccolto in sacchetti di tela e portato a casa per essere poi scambiato in Piemonte.
Compito di noi ragazzini era quello di riempire le vasche con acqua di mare ed andare nel bosco a cercare legna per il fuoco ed era un gran spasso, perché riempiendo le vasche facevamo il bagno e, nella stagione dei nidi, giravamo tutta la collina che allora non era infestata di ville, giardini, strade, parcheggi e ripetitori.
Inoltre tutte le capre della zona ci venivano a leccare perché eravamo sempre incrostati di sale.
Fortunatamente avevamo a disposizione un’infinità di materia prima: il mare.
Giumìn, che aveva fatto il marinaio, e gli altri grandi, si erano procurati, probabilmente rubandole nel cantiere navale, alcune grandi lamiere rettangolari; rialzandone a martellate i bordi si ottenevano delle rudimentali vasche piane di quasi due metri quadrati di superficie.
Trasportate in spiaggia poste su treppiedi in ferro sopra un fuoco di sterpi e legna, venivano riempite di acqua di mare.
Con l’ebollizione e l’evaporazione si depositava sul fondo uno strato di sale un po’ amaro ma commestibile; una volta evaporata tutta l’acqua ed asciugato il sale questo veniva raschiato con una spatola di legno, raccolto in sacchetti di tela e portato a casa per essere poi scambiato in Piemonte.
Compito di noi ragazzini era quello di riempire le vasche con acqua di mare ed andare nel bosco a cercare legna per il fuoco ed era un gran spasso, perché riempiendo le vasche facevamo il bagno e, nella stagione dei nidi, giravamo tutta la collina che allora non era infestata di ville, giardini, strade, parcheggi e ripetitori.
Inoltre tutte le capre della zona ci venivano a leccare perché eravamo sempre incrostati di sale.
Andora: la zona di spiaggia dove facevamo bollire l’acqua di mare per ricavarne il sale.

U Gin de Testùn, marito di Gilìna era il padre di Milì moglie di Angeòttu, nonno di Annamaria e bisnonno di Claudio Biasibetti.
Era un arzillo vecchietto minuto, quasi calvo e con un paio di favolosi “mustasci”* ingialliti e bruciacchiati dal fumo.
La domenica, dopo messa, i vecchi del paese tra cui ricordo Pipìn de l’òa, u Muèttu, Chicòttu, u Tibì, u Bainòttu, Nanìn de Mìlia, Battistìn, Battistìn de Fiuìna, Petalìn, Bacìccia, Bacicìn de Lasagna, Nanòlu, Luènsu, Michè, Michè u Grossu ed altri si sedevano fuori del portone della chiesa per discutere gli importanti avvenimenti della settimana che vertevano sul crollo del muro nell’uliveto di Culetìn; sul parto della capra del Ca’ d’Ineia; sul fatto che u Tatùlu che abitava ad Andora in regione Noceto ma che era un lontano cugino di Nanòlu avesse sposato una di Imperia …
U Gin de Testùn sedeva con gli altri, caricava una corta pipetta fatta col torsolo della pannocchia del granoturco, accendeva e si godeva la sua pipata.
Terminato il tabacco, con un arnese fatto con l’osso di un pollo, ripuliva il fornello della pipa dai residui di tabacco, dalla cenere e dalla saliva che vi era colata, raccoglieva il tutto nel palmo della mano callosa, lo amalgamava sino a formare una pallina grossa come una biglia e se la ficcava in un angolo della bocca masticandola con soddisfazione.
Noi ragazzini lo guardavamo facendo finta di niente e dicendoci: “u regüma cume ina cròva”**.
* Baffoni.
** Rumina come una capra.
Era un arzillo vecchietto minuto, quasi calvo e con un paio di favolosi “mustasci”* ingialliti e bruciacchiati dal fumo.
La domenica, dopo messa, i vecchi del paese tra cui ricordo Pipìn de l’òa, u Muèttu, Chicòttu, u Tibì, u Bainòttu, Nanìn de Mìlia, Battistìn, Battistìn de Fiuìna, Petalìn, Bacìccia, Bacicìn de Lasagna, Nanòlu, Luènsu, Michè, Michè u Grossu ed altri si sedevano fuori del portone della chiesa per discutere gli importanti avvenimenti della settimana che vertevano sul crollo del muro nell’uliveto di Culetìn; sul parto della capra del Ca’ d’Ineia; sul fatto che u Tatùlu che abitava ad Andora in regione Noceto ma che era un lontano cugino di Nanòlu avesse sposato una di Imperia …
U Gin de Testùn sedeva con gli altri, caricava una corta pipetta fatta col torsolo della pannocchia del granoturco, accendeva e si godeva la sua pipata.
Terminato il tabacco, con un arnese fatto con l’osso di un pollo, ripuliva il fornello della pipa dai residui di tabacco, dalla cenere e dalla saliva che vi era colata, raccoglieva il tutto nel palmo della mano callosa, lo amalgamava sino a formare una pallina grossa come una biglia e se la ficcava in un angolo della bocca masticandola con soddisfazione.
Noi ragazzini lo guardavamo facendo finta di niente e dicendoci: “u regüma cume ina cròva”**.
* Baffoni.
** Rumina come una capra.
Adriano era il figlio di Giuseppina, sorella di Angiùlin e di Gigèttu, che aveva sposato un casellante delle ferrovie, ed abitava con suo fratello Elio nel casello ferroviario sotto l’attuale villaggio Conca Verde.
Un giorno dei primi mesi del quarantaquattro Adriano mi disse che aveva trovato un vecchio fucile ‘91 della prima guerra mondiale, ma ancora in dotazione all’esercito italiano prima dell’otto settembre.
Nelle razzie delle caserme io avevo prelevato alcuni caricatori da sei colpi di questo tipo di fucile.
Il pomeriggio stesso portammo il fucile ed un caricatore da sei colpi sullo “scoglio a picco” nella scogliera sotto il casello; questa roccia sporgendo di cinque o sei metri sul livello del mare, costituiva un ottimo piazzamento per sparare in ogni direzione.
Caricammo il fucile e cercammo un bersaglio; caso volle che alla foce del torrente Merula, a circa duecento metri da riva ed a oltre un chilometro dalla nostra postazione si trovasse una barca con una persona che pescava al bolentino.
Ci sdraiammo appoggiammo il fucile alla spalla e, tre colpi ciascuno, gli scaricammo addosso l’intero caricatore ammaccandoci la spalla per il rinculo.
Fortunatamente nessuna delle sei pallottole lo raggiunse e credo che non se ne sia neppure accorto, forse confondendo il sibilo dei proiettili con il ronzio di api o mosche di passaggio.
Non ho mai saputo chi fosse.
Un giorno dei primi mesi del quarantaquattro Adriano mi disse che aveva trovato un vecchio fucile ‘91 della prima guerra mondiale, ma ancora in dotazione all’esercito italiano prima dell’otto settembre.
Nelle razzie delle caserme io avevo prelevato alcuni caricatori da sei colpi di questo tipo di fucile.
Il pomeriggio stesso portammo il fucile ed un caricatore da sei colpi sullo “scoglio a picco” nella scogliera sotto il casello; questa roccia sporgendo di cinque o sei metri sul livello del mare, costituiva un ottimo piazzamento per sparare in ogni direzione.
Caricammo il fucile e cercammo un bersaglio; caso volle che alla foce del torrente Merula, a circa duecento metri da riva ed a oltre un chilometro dalla nostra postazione si trovasse una barca con una persona che pescava al bolentino.
Ci sdraiammo appoggiammo il fucile alla spalla e, tre colpi ciascuno, gli scaricammo addosso l’intero caricatore ammaccandoci la spalla per il rinculo.
Fortunatamente nessuna delle sei pallottole lo raggiunse e credo che non se ne sia neppure accorto, forse confondendo il sibilo dei proiettili con il ronzio di api o mosche di passaggio.
Non ho mai saputo chi fosse.
Bacicìn de Lasagna, nonno di Fernando e Lucianetto, abitava a Ca’ Tiaferi, sotto la casa di Baciccia ed era affetto dal morbo di Parkinson che gli faceva tremolare la mano destra.
Alla domenica, quando i vecchi si sedevano dopo messa fuori della chiesa per le solite chiacchiere, Bacicìn infilava la mano destra nei larghi pantaloni di fustagno, forse vergognandosi del tremolìo che la scuoteva, solo che questo si trasmetteva alla stoffa alzandola ed abbassandola ritmicamente.
Noi ragazzi, giocando alla “patta” e rincorrendoci attorno alla palma del sagrato, osservavamo il movimento dicendoci “Mia c’u se ne fa üna, mia cu se ne fa üna !”*.
Bacicìn ci osservava con gli occhi lagrimosi e tristi forse comprendendo quanto accadeva.
Oggi ho rimorso per quelle irriverenze e mi sento triste al pensiero di quanto male, nella mia incoscienza, posso aver fatto a Bacicìn.
Ma Bacicìn de Lasagna era famoso soprattutto per la commedia che inscenava in primavera quando, con il carro pieno di attrezzi e la mula a trainarlo, partiva per andare ad Andora a coltivare “I ciai”**.
Già il carico costituiva un’impresa perché doveva essere bilanciato, poi bisognava scenderne una parte per controllare di non aver dimenticato qualche attrezzo importante, infine nessun manico doveva sporgere dal carro.
Tutto questo con costante accompagnamento di giaculatorie, nonché dalle raccomandazioni della moglie: “Bacicìn va cianìn, me raccumandu”.
Ma la scena madre che raccoglieva spettatori da tutta Rollo era il momento della partenza: Bacicìn, salito a cassetta sul carro, tolto il freno ed impugnato lo staffile, iniziava a farlo schioccare e ad incitare la mula con versi vari.
Il povero animale, nello sforzo per vincere l’inerzia,
lasciava partire certe scorregge che parevano vele lacerate e finalmente, tra l’ilarità generale, Bacicìn partiva per i ciai!
* guarda che se ne fà una.
** campi in pianura.
Alla domenica, quando i vecchi si sedevano dopo messa fuori della chiesa per le solite chiacchiere, Bacicìn infilava la mano destra nei larghi pantaloni di fustagno, forse vergognandosi del tremolìo che la scuoteva, solo che questo si trasmetteva alla stoffa alzandola ed abbassandola ritmicamente.
Noi ragazzi, giocando alla “patta” e rincorrendoci attorno alla palma del sagrato, osservavamo il movimento dicendoci “Mia c’u se ne fa üna, mia cu se ne fa üna !”*.
Bacicìn ci osservava con gli occhi lagrimosi e tristi forse comprendendo quanto accadeva.
Oggi ho rimorso per quelle irriverenze e mi sento triste al pensiero di quanto male, nella mia incoscienza, posso aver fatto a Bacicìn.
Ma Bacicìn de Lasagna era famoso soprattutto per la commedia che inscenava in primavera quando, con il carro pieno di attrezzi e la mula a trainarlo, partiva per andare ad Andora a coltivare “I ciai”**.
Già il carico costituiva un’impresa perché doveva essere bilanciato, poi bisognava scenderne una parte per controllare di non aver dimenticato qualche attrezzo importante, infine nessun manico doveva sporgere dal carro.
Tutto questo con costante accompagnamento di giaculatorie, nonché dalle raccomandazioni della moglie: “Bacicìn va cianìn, me raccumandu”.
Ma la scena madre che raccoglieva spettatori da tutta Rollo era il momento della partenza: Bacicìn, salito a cassetta sul carro, tolto il freno ed impugnato lo staffile, iniziava a farlo schioccare e ad incitare la mula con versi vari.
Il povero animale, nello sforzo per vincere l’inerzia,
lasciava partire certe scorregge che parevano vele lacerate e finalmente, tra l’ilarità generale, Bacicìn partiva per i ciai!
* guarda che se ne fà una.
** campi in pianura.
La vita degli abitanti di Rollo in quegli anni era, dalla nascita alla morte, un continuo sacrificio ed una continua fatica.
Si cominciava da bambini a portare gli animali al pascolo; ad andare quotidianamente al pozzo a riempire i secchi d’acqua per il fabbisogno della cucina e per lavarsi, per quel poco che ci si lavava; ad aiutare i grandi portando le ceste di scaglie quando ricostruivano i muri a secco crollati nelle campagne; a svuotare le giare che servivano da cessi ed a trasportare la latrina negli orti perché non contenendo detersivi, costituiva l’unico fertilizzante conosciuto assieme al letame delle vacche e delle capre.
Bisognava stare attenti a quello dei conigli e delle galline perché era troppo forte e, se si bruciava la verdura dell’orto, erano legnate sicure.
Il tutto condito dal freddo in inverno perchè non esisteva riscaldamento se non la stufa a legna in cucina ed il mattone riscaldato e fasciato in una vecchia calza di lana da portare a letto e ricondito dal caldo in estate, specie di notte perché i vecchi “paiassùi”* di foglia di granoturco e i materassi di crine erano un inferno di calore e di insetti.
Solo Fiuìna aveva un materasso di lana.
Il sogno di noi ragazzini era quello di poter diventare presto grandi per poter andare “a navigare” immaginando avventure come quelle dei pirati e dei bucanieri i “fratelli della costa” e senza comprendere le facce stanche e deluse dei nostri padri quando, dopo anni, ritornavano da quelle “avventure” e a quarantanni sembravano averne il doppio.
I vecchi poi finivano di rovinarsi il fisico in “case” umide e fredde, senza luce, senza acqua, senza riscaldamento e senza servizi igienici, lavorando dall’alba al tramonto e mangiando quel che c’era quando ce n’era.
Durante i funerali sentivo dire dai vecchi: “dopu tanta fatiga, dopu tantu penò u l’è andoitu in Vaè”** e mi chiedevo dove fosse Vaè, perché un giorno o l’altro volevo andarci per vedere se ci fossero dei nidi di testenere o di coderosse.
Dopo qualche anno scopersi che Vaè era il cimitero.
* sacco tipo materasso riempito con il rivestimento della pannocchia di granoturco
** “Dopo tanta fatica, dopo tanto penare è andato a Vaè”.
Si cominciava da bambini a portare gli animali al pascolo; ad andare quotidianamente al pozzo a riempire i secchi d’acqua per il fabbisogno della cucina e per lavarsi, per quel poco che ci si lavava; ad aiutare i grandi portando le ceste di scaglie quando ricostruivano i muri a secco crollati nelle campagne; a svuotare le giare che servivano da cessi ed a trasportare la latrina negli orti perché non contenendo detersivi, costituiva l’unico fertilizzante conosciuto assieme al letame delle vacche e delle capre.
Bisognava stare attenti a quello dei conigli e delle galline perché era troppo forte e, se si bruciava la verdura dell’orto, erano legnate sicure.
Il tutto condito dal freddo in inverno perchè non esisteva riscaldamento se non la stufa a legna in cucina ed il mattone riscaldato e fasciato in una vecchia calza di lana da portare a letto e ricondito dal caldo in estate, specie di notte perché i vecchi “paiassùi”* di foglia di granoturco e i materassi di crine erano un inferno di calore e di insetti.
Solo Fiuìna aveva un materasso di lana.
Il sogno di noi ragazzini era quello di poter diventare presto grandi per poter andare “a navigare” immaginando avventure come quelle dei pirati e dei bucanieri i “fratelli della costa” e senza comprendere le facce stanche e deluse dei nostri padri quando, dopo anni, ritornavano da quelle “avventure” e a quarantanni sembravano averne il doppio.
I vecchi poi finivano di rovinarsi il fisico in “case” umide e fredde, senza luce, senza acqua, senza riscaldamento e senza servizi igienici, lavorando dall’alba al tramonto e mangiando quel che c’era quando ce n’era.
Durante i funerali sentivo dire dai vecchi: “dopu tanta fatiga, dopu tantu penò u l’è andoitu in Vaè”** e mi chiedevo dove fosse Vaè, perché un giorno o l’altro volevo andarci per vedere se ci fossero dei nidi di testenere o di coderosse.
Dopo qualche anno scopersi che Vaè era il cimitero.
* sacco tipo materasso riempito con il rivestimento della pannocchia di granoturco
** “Dopo tanta fatica, dopo tanto penare è andato a Vaè”.
Rollo: personaggi degli anni 20-30.
Seduti gli ultraottantenni: in piedi i giovanotti.
Il primo seduto a sinistra: Petalìn
L’ultimo in piedi a destra: U Tibì.
Seduti gli ultraottantenni: in piedi i giovanotti.
Il primo seduto a sinistra: Petalìn
L’ultimo in piedi a destra: U Tibì.

Dagli ultimi mesi del quarantadue sino alla fine della guerra, una o due notti la settimana, passava un aereo degli alleati che, chissà perché, venne chiamato Pippo e che lasciava cadere a caso un po’ dovunque grappoli di spezzoni incendiari e piccole bombe con delle curiose alette nella parte posteriore, come quelle dei proiettili da mortaio.
Gli spezzoni erano costituiti da un parallelepipedo a base esagonale di dieci centimetri ed alti circa quaranta, in lega di alluminio, la cui cavità conteneva l’esplosivo, credo fosforo.
Ad una delle estremità era fissato un piccolo percussore cilindrico con una punta a spillo che nell’urto sul terreno batteva contro il detonatore facendo esplodere l’ordigno.
Proprio il possesso di questi percussori era diventato una mania tra noi ragazzi, perciò ci davamo da fare per rintracciarli dove Pippo li aveva sganciati la notte prima.
Un giorno pascolando Gialì sopra un uliveto chiamato “reinàudu” trovai uno spezzone inesploso; naturalmente me lo portai a casa ma, memore di quanto era successo con le mine sotto il materasso, non lo nascosi in casa ma nei ruderi di Ca’ Survòne in quello che oggi è l’appartamento dell’ingegnere Colombo.
Dopo alcuni giorni, volendo recuperare il percussore, mentre Giumìn e Pinuccia erano in un altro uliveto, pensai a come far esplodere lo spezzone ma non riuscii ad escogitare altra soluzione che quella di scagliarlo ripetutamente contro un muro.
Seguì una mezz’ora di insuccessi poi finalmente l’ordigno esplose con una violenta fiammata di oltre due metri, talmente calda da sembrare bianca e da cui sprigionavano dense ed alte volute di fumo.
Poiché nel frattempo stavano passando ad alta quota alcune formazioni di fortezze volanti B 17 che andavano a bombardare Torino, mi spaventai ed andai al pozzo a riempire un secchio d’acqua e lo rovesciai sullo spezzone che continuava a bruciare.
Il risultato fu una colonna di fumo spessa dieci metri ed alta una cinquantina che fece scappare Gialì nella stalla.
Un caccia “spitfire” di quelli con le ali larghe, che probabilmente era di scorta ai bombardieri, scese volteggiando e passò rasente a Ca’ Bernei; vidi chiaramente il pilota che mi guardava attraverso i vetri della carlinga.
Poco dopo giunsero Baciccia, Giumìn e u Bainòttu attirati dal gran fumo.
Giumìn resosi conto dell’accaduto strappò una “fèrla” cioè un rametto dritto da un ulivo e me le suonò con quella, ma non mi fece molto male perché era ancora tenera e flessibile.
Gli spezzoni erano costituiti da un parallelepipedo a base esagonale di dieci centimetri ed alti circa quaranta, in lega di alluminio, la cui cavità conteneva l’esplosivo, credo fosforo.
Ad una delle estremità era fissato un piccolo percussore cilindrico con una punta a spillo che nell’urto sul terreno batteva contro il detonatore facendo esplodere l’ordigno.
Proprio il possesso di questi percussori era diventato una mania tra noi ragazzi, perciò ci davamo da fare per rintracciarli dove Pippo li aveva sganciati la notte prima.
Un giorno pascolando Gialì sopra un uliveto chiamato “reinàudu” trovai uno spezzone inesploso; naturalmente me lo portai a casa ma, memore di quanto era successo con le mine sotto il materasso, non lo nascosi in casa ma nei ruderi di Ca’ Survòne in quello che oggi è l’appartamento dell’ingegnere Colombo.
Dopo alcuni giorni, volendo recuperare il percussore, mentre Giumìn e Pinuccia erano in un altro uliveto, pensai a come far esplodere lo spezzone ma non riuscii ad escogitare altra soluzione che quella di scagliarlo ripetutamente contro un muro.
Seguì una mezz’ora di insuccessi poi finalmente l’ordigno esplose con una violenta fiammata di oltre due metri, talmente calda da sembrare bianca e da cui sprigionavano dense ed alte volute di fumo.
Poiché nel frattempo stavano passando ad alta quota alcune formazioni di fortezze volanti B 17 che andavano a bombardare Torino, mi spaventai ed andai al pozzo a riempire un secchio d’acqua e lo rovesciai sullo spezzone che continuava a bruciare.
Il risultato fu una colonna di fumo spessa dieci metri ed alta una cinquantina che fece scappare Gialì nella stalla.
Un caccia “spitfire” di quelli con le ali larghe, che probabilmente era di scorta ai bombardieri, scese volteggiando e passò rasente a Ca’ Bernei; vidi chiaramente il pilota che mi guardava attraverso i vetri della carlinga.
Poco dopo giunsero Baciccia, Giumìn e u Bainòttu attirati dal gran fumo.
Giumìn resosi conto dell’accaduto strappò una “fèrla” cioè un rametto dritto da un ulivo e me le suonò con quella, ma non mi fece molto male perché era ancora tenera e flessibile.
Ca’ era profumo di legno d’ulivo che bruciava nella vecchia stufa; di mele a maturare sulle sporgenze della volta a vela di camera mia; di “menestrùn” che Pinuccia, con due patate un cavolo e quattro fagioli, elaborava in una golosità profumata di boragine e basilico.
Ca’ era il canto del picéttu* in gabbia dietro la porta; il flauto di Pan tra le fessure dell’antica finestra con stucco screpolato dal vento e dal tempo; il ticchettio della “Singer” di Pinuccia che la sera rattoppava, cuciva e rammendava i pochi indumenti custoditi nel comò e nel guardavì.
Ca’ era il pavimento in leggera pendenza e la fessura lungo la linea di incontro con la parete in pietra; una o due volte l’anno Giumìn faceva bollire un pentolone d’acqua che rovesciava sul pavimento e che colava, ancora bollente, dentro le fessure del muro sterminando le formiche argentine che vi si annidavano.
Ca’ era la cantina con la botte dove, scalzo, pestavo i pochi acini di “cancarùn”** del vigneto di Ca’ Survòne, e con i grappoli di sòrbole appesi a maturare ai fili tesi da parete a parete; era la stalla di Gialì con la porta incastonata in un arco di pietra scolpita.
Ca’ era Pinuccia che mi curava con amore quando, caduto da un ulivo “au Pràu” per prendere un nido avevo strisciato lungo un muro di quattro metri scarnificandomi la schiena o quando, per rubare i fichi di Bigoni, ero caduto sul cancelletto rimanendovi infilzato.
Ca’ era l’orgoglio nello sguardo burbero di Gimìn che mi valutava e mi vedeva crescere forte, libero e indipendente come un capretto e mi portava lo “zebibbu” dalla Tunisia, le bacchette in avorio dal Giappone e il coltello col manico in osso di renna dalla Finlandia.
Ca’ era … era Ca’!
* Pettirosso.
** Vitigno tipico con acini dal succo colorante.
Ca’ era il canto del picéttu* in gabbia dietro la porta; il flauto di Pan tra le fessure dell’antica finestra con stucco screpolato dal vento e dal tempo; il ticchettio della “Singer” di Pinuccia che la sera rattoppava, cuciva e rammendava i pochi indumenti custoditi nel comò e nel guardavì.
Ca’ era il pavimento in leggera pendenza e la fessura lungo la linea di incontro con la parete in pietra; una o due volte l’anno Giumìn faceva bollire un pentolone d’acqua che rovesciava sul pavimento e che colava, ancora bollente, dentro le fessure del muro sterminando le formiche argentine che vi si annidavano.
Ca’ era la cantina con la botte dove, scalzo, pestavo i pochi acini di “cancarùn”** del vigneto di Ca’ Survòne, e con i grappoli di sòrbole appesi a maturare ai fili tesi da parete a parete; era la stalla di Gialì con la porta incastonata in un arco di pietra scolpita.
Ca’ era Pinuccia che mi curava con amore quando, caduto da un ulivo “au Pràu” per prendere un nido avevo strisciato lungo un muro di quattro metri scarnificandomi la schiena o quando, per rubare i fichi di Bigoni, ero caduto sul cancelletto rimanendovi infilzato.
Ca’ era l’orgoglio nello sguardo burbero di Gimìn che mi valutava e mi vedeva crescere forte, libero e indipendente come un capretto e mi portava lo “zebibbu” dalla Tunisia, le bacchette in avorio dal Giappone e il coltello col manico in osso di renna dalla Finlandia.
Ca’ era … era Ca’!
* Pettirosso.
** Vitigno tipico con acini dal succo colorante.
Nell’estate del quarantaquattro Giumìn e Pinuccia andarono nei partigiani perché i San Marco stavano rastrellando i paesi in cerca di uomini e donne validi al lavoro per l’organizzazione TODT, che non ho mai saputo cosa fosse, e ritornavano a Ca’ Bernei solo qualche volta di notte per prendere dei vestiti e mangiare un po’ di minestra calda.
Io dormivo solo ma non avevo paura perché nessuno mi aveva spiegato che da soli bisognava averne, inoltre c’era Gialì che ogni tanto, salendo a dormire nella mangiatoia in legno, dava dei calci alle tavole e la sentivo dalla mia cameretta.
A Bande de Là, nello stesso periodo, la casa del defunto Tibì era stata requisita da una pattuglia di soldati tedeschi comandata dal sergente Bruno che mi faceva sparare con la “Maschinenpistole” di quelle col calcio in ferro sagomato e ripiegabile e si era ferito facendo esplodere una delle mie spolette per dimostrarmi che era pericolosa.
Il sergente Bruno, ogni tanto, mi regalava una scatoletta piena di carne che però non sapevo aprire; allora la portavo da Grillo Nero che la apriva con un ferro speciale e ce la mangiavamo metà ciascuno perché anche lui aveva fame avendo mangiato solo l’ostia.
Una sera, al tramonto, ritornai a casa, misi Gialì nella stalla, entrai in casa e trovai Giumìn seduto al tavolo con due partigiani, uno dei quali in pantaloni corti e con una gamba fasciata, che stavano bevendo da un fiasco di cancarùn sul tavolo.
Pinuccia era in cucina e stava facendo bollire acqua e sale per disinfettare la ferita di quello in pantaloni corti.
Avevo appena fatto a tempo a dare un avido sguardo ai due “sten” ed all’automatico russo di quelli col caricatore rotondo, appoggiati alla parete, quando la porta che, come sempre a casa era solo accostata, si aperse ed entrò il sergente Bruno con la Maschinenpistole appesa alla spalla con la cinghia di corda.
Ci fu un attimo di silenzio e di immobilità poi mi feci incontro al sergente Bruno e questi, lentamente, si sfilò dalla spalla la mitraglietta, con calma la posò accanto agli sten, prese una scatoletta di carne dalla tasca e saluto Giumìn, spiegandogli, nel suo italiano, che non avendomi visto, mi aveva portato qualcosa da mangiare.
Giumìn, con uno strano tic alla bocca, disse: “Pinuccia porta in àutru gòttu”.
Il sergente Bruno sedette, sempre ignorando i due partigiani, sorseggiò un bicchiere poi prese la sua Maschinenpistole, la mise in spalla ed uscì salutando tranquillamente e lasciandomi la scatoletta.
Lo rividi a Rollo dopo quasi trentanni e non era più l’imponente sottufficiale tedesco, ma un normale uomo dallo sguardo che vagava lontano, tranquillo ed in pace con se stesso.
Io dormivo solo ma non avevo paura perché nessuno mi aveva spiegato che da soli bisognava averne, inoltre c’era Gialì che ogni tanto, salendo a dormire nella mangiatoia in legno, dava dei calci alle tavole e la sentivo dalla mia cameretta.
A Bande de Là, nello stesso periodo, la casa del defunto Tibì era stata requisita da una pattuglia di soldati tedeschi comandata dal sergente Bruno che mi faceva sparare con la “Maschinenpistole” di quelle col calcio in ferro sagomato e ripiegabile e si era ferito facendo esplodere una delle mie spolette per dimostrarmi che era pericolosa.
Il sergente Bruno, ogni tanto, mi regalava una scatoletta piena di carne che però non sapevo aprire; allora la portavo da Grillo Nero che la apriva con un ferro speciale e ce la mangiavamo metà ciascuno perché anche lui aveva fame avendo mangiato solo l’ostia.
Una sera, al tramonto, ritornai a casa, misi Gialì nella stalla, entrai in casa e trovai Giumìn seduto al tavolo con due partigiani, uno dei quali in pantaloni corti e con una gamba fasciata, che stavano bevendo da un fiasco di cancarùn sul tavolo.
Pinuccia era in cucina e stava facendo bollire acqua e sale per disinfettare la ferita di quello in pantaloni corti.
Avevo appena fatto a tempo a dare un avido sguardo ai due “sten” ed all’automatico russo di quelli col caricatore rotondo, appoggiati alla parete, quando la porta che, come sempre a casa era solo accostata, si aperse ed entrò il sergente Bruno con la Maschinenpistole appesa alla spalla con la cinghia di corda.
Ci fu un attimo di silenzio e di immobilità poi mi feci incontro al sergente Bruno e questi, lentamente, si sfilò dalla spalla la mitraglietta, con calma la posò accanto agli sten, prese una scatoletta di carne dalla tasca e saluto Giumìn, spiegandogli, nel suo italiano, che non avendomi visto, mi aveva portato qualcosa da mangiare.
Giumìn, con uno strano tic alla bocca, disse: “Pinuccia porta in àutru gòttu”.
Il sergente Bruno sedette, sempre ignorando i due partigiani, sorseggiò un bicchiere poi prese la sua Maschinenpistole, la mise in spalla ed uscì salutando tranquillamente e lasciandomi la scatoletta.
Lo rividi a Rollo dopo quasi trentanni e non era più l’imponente sottufficiale tedesco, ma un normale uomo dallo sguardo che vagava lontano, tranquillo ed in pace con se stesso.
Teejòla, moglie di Chicòttu, era una donna energica che aveva allevato tre figli: Ambrujìn che si era fatto prete e mi regalava sempre i santini; Giacumìn che faceva il marinaio ed era amico di mio padre e Milì che era fantina* e che lavorò per molti anni all’ufficio postale di Andora.
Chicòttu era la prima voce nel coro in chiesa e nei vespri della domenica pomeriggio intonava sempre lui i salmi.
Teejòla al mattino presto, subito dopo la messa delle sei, andava a raccogliere le olive in un terreno vicino alla mulattiera per Andora nel tratto detto “dau zenebrìn”** ed io passavo appositamente di là perché nell’inverno del quarantaquattro, quando Giumìn e Pinuccia erano nei partigiani, mangiavo qualcosa dal prete, quando c’era, ma avevo sempre fame.
Avevo sempre fame anche prima però.
Teejòla aveva sempre un pugno di fichi secchi per me, di quelli con la mandorla dentro e che avevano attorno come una bava di zucchero.
Io cercavo di farmeli durare per tutta la mattina ma quando arrivavo a scuola me li ero mangiati tutti e guardavo gli altri far colazione.
Mi pare di sentire il sapore di quei fichi e lo scricchiolio dei semini sotto i denti.
* Nubile.
** Dal ginepro.
Chicòttu era la prima voce nel coro in chiesa e nei vespri della domenica pomeriggio intonava sempre lui i salmi.
Teejòla al mattino presto, subito dopo la messa delle sei, andava a raccogliere le olive in un terreno vicino alla mulattiera per Andora nel tratto detto “dau zenebrìn”** ed io passavo appositamente di là perché nell’inverno del quarantaquattro, quando Giumìn e Pinuccia erano nei partigiani, mangiavo qualcosa dal prete, quando c’era, ma avevo sempre fame.
Avevo sempre fame anche prima però.
Teejòla aveva sempre un pugno di fichi secchi per me, di quelli con la mandorla dentro e che avevano attorno come una bava di zucchero.
Io cercavo di farmeli durare per tutta la mattina ma quando arrivavo a scuola me li ero mangiati tutti e guardavo gli altri far colazione.
Mi pare di sentire il sapore di quei fichi e lo scricchiolio dei semini sotto i denti.
* Nubile.
** Dal ginepro.
Negli anni della seconda guerra mondiale a Rollo qualunque integrazione alla scarsa dieta imperante era accolta con entusiasmo.
Adriano ed io davamo il nostro contributo andando spesso a caccia di uccelletti, specie nel periodo invernale, usando il vischio con il sistema delle “trappe” che erano bacchette di legno cosparse di vischio che venivano poste vicino ai frutti dell’edera o sui rami degli alberi con qualche gabbia da richiamo.
Le “busche” erano steli di un’erba secca e rigida, anch’essi cosparsi di vischio che venivano disposti come a formare una rete ai bordi delle pozzanghere nei pressi di una sorgente.
I “ferretti” erano trappoline a molla con un verme di richiamo e si usavano specialmente dopo una nevicata: si andava in una stalla a fare provvista di quelle larve giallastre e coriacee chiamate “càmue”, si zappavano uno o due metri quadrati di terreno dopo averlo liberato dalla neve e vi si piazzavano le trappole mascherandole con terriccio e lasciando fuori solo la larva prigioniera ad agitarsi.
La caccia al pettirosso si effettuava col “gaggiùn e u piccèttu”* cioè con la gabbia ed un pettirosso prigioniero.
Questa caccia era la più divertente perché il pettirosso, fortemente territoriale, quando vedeva invaso il suo territorio da quello in gabbia gli si precipitava contro finendo sempre contro le “trappe” invischiate poste sulla gabbia.
Una sera ci morì il pettirosso.
Il giorno dopo Adriano ed io prendemmo un pomodoro campanella di quelli oblunghi, gli infilzammo ad una estremità alcune piume della coda del pettirosso defunto, lo infilammo nella gabbia legato ad uno spago lungo una ventina di metri tale da permetterci di farlo ballonzolare su e giù nascosti dietro un cespuglio imitandone il canto con due monete battute assieme.
Prendemmo più pettirossi col pomodoro che con l’uccello vero.
* Gabbione e pettirosso.
Adriano ed io davamo il nostro contributo andando spesso a caccia di uccelletti, specie nel periodo invernale, usando il vischio con il sistema delle “trappe” che erano bacchette di legno cosparse di vischio che venivano poste vicino ai frutti dell’edera o sui rami degli alberi con qualche gabbia da richiamo.
Le “busche” erano steli di un’erba secca e rigida, anch’essi cosparsi di vischio che venivano disposti come a formare una rete ai bordi delle pozzanghere nei pressi di una sorgente.
I “ferretti” erano trappoline a molla con un verme di richiamo e si usavano specialmente dopo una nevicata: si andava in una stalla a fare provvista di quelle larve giallastre e coriacee chiamate “càmue”, si zappavano uno o due metri quadrati di terreno dopo averlo liberato dalla neve e vi si piazzavano le trappole mascherandole con terriccio e lasciando fuori solo la larva prigioniera ad agitarsi.
La caccia al pettirosso si effettuava col “gaggiùn e u piccèttu”* cioè con la gabbia ed un pettirosso prigioniero.
Questa caccia era la più divertente perché il pettirosso, fortemente territoriale, quando vedeva invaso il suo territorio da quello in gabbia gli si precipitava contro finendo sempre contro le “trappe” invischiate poste sulla gabbia.
Una sera ci morì il pettirosso.
Il giorno dopo Adriano ed io prendemmo un pomodoro campanella di quelli oblunghi, gli infilzammo ad una estremità alcune piume della coda del pettirosso defunto, lo infilammo nella gabbia legato ad uno spago lungo una ventina di metri tale da permetterci di farlo ballonzolare su e giù nascosti dietro un cespuglio imitandone il canto con due monete battute assieme.
Prendemmo più pettirossi col pomodoro che con l’uccello vero.
* Gabbione e pettirosso.
Don Dell’Erba il prete, detto Grillo Nero, possedeva una radio e in canonica negli ultimi mesi di guerra i vecchi si riunivano per ascoltare i messaggi di un tizio che parlava da una città chiamata Londra e che, tempo prima, Mussolini aveva detto di aver bombardato e distrutto.
Grillo Nero possedeva anche un grosso macinino e quando noi ragazzi riuscivamo ad andare in canonica sperando di sentire il tizio di Londra ci mettevano al macinino bloccato al bordo del tavolo in un’altra stanza a macinare grano o granoturco.
Oltre al lavoro al macinino i vecchi ci facevano pestare in un grosso mortaio dei chicchi di granoturco mescolati a ceci e piselli secchi, impastando poi i frammenti con la crusca e l’acqua per fare il pastone per le galline.
Quando le galline mangiavano quel pastone facevano più uova.
Non sono mai riuscito a capire come funzionasse la radio senza elettricità.
Grillo Nero possedeva anche un grosso macinino e quando noi ragazzi riuscivamo ad andare in canonica sperando di sentire il tizio di Londra ci mettevano al macinino bloccato al bordo del tavolo in un’altra stanza a macinare grano o granoturco.
Oltre al lavoro al macinino i vecchi ci facevano pestare in un grosso mortaio dei chicchi di granoturco mescolati a ceci e piselli secchi, impastando poi i frammenti con la crusca e l’acqua per fare il pastone per le galline.
Quando le galline mangiavano quel pastone facevano più uova.
Non sono mai riuscito a capire come funzionasse la radio senza elettricità.
Teejìn, moglie del Ca’ d’Ineia, che mi regala un palloncino da gonfiare col fiato e che mi si rompe prima di arrivare a Ca’ Bernei.
Rabbia e rimpianto.
Grillo Nero che mi porta a servire messa a Capo Mele nell’antica cappella detta “La Madonna delle Penne”.
Cesare de Carmelìn che gioca a biglie nella polvere della strada davanti alla scuola; si gioca al “Triangolo”, al “Papa”, Pormu e stecca”, con le terrole, le marmuine, le vedrole e le cristalline”.
Giumìn, ferito negli ultimi giorni di guerra per difendere il ponte sul Merula che i tedeschi avevano minato e volevano far saltare. I buchi neri e sanguinanti nei polpacci e la bacinella con acqua e sale sul tavolo in cucina.
Adriano ed io che portiamo Gialì a far coprire dal becco a Stellanello. A piedi andata e ritorno: uno spasso.
Culetìn che, con una gamba rotta per una caduta, viene adagiata su una scala in legno con un cuscino sotto la gamba e portata a casa da Angiulìn e Nanìn de Mìlia.
Due (o tre?) anziane Signore villeggianti che mi insegnano a suonare il piano in un alloggio di Cae Suttae.
Adriano ed io seduti sul terrazzo del Muettu mentre i grandi lavoravano nel frantoio sottostante. C’è una grande luna piena.
Battistìn u bancaò che mi tira una boccia perché gli dico che sono quadrate e lui non è capace di farle rotonde.
Pinuccia e Anna che spargono i sacchi di fiori di ginestra lungo il percorso della processione del Corpus Domini dalla chiesa a Bande de Là, a Ca’ Bernei, a Cae Suttae.
Adriano che dice a Giuanìn da Culetta: “Se ti ci metti il latte di fico acerbo ti diventa più grosso”. Infatti!
L’altissimo letto di Gigettu dove ho dormito la notte durante la quale è nata Jose perché Pinuccia faceva la levatrice.
Battistìn de Fiuìna che mi tiene la scala mentre vado a prendere i nidi di passero nel sottotetto della sacrestia, passando da un foro della parete Ovest. Sensazioni di caldo e polvere.
“Te rogamus audi nos” Grillo nero con le pie donne che va negli uliveti per le rogazioni nei periodi di siccità ed io che porto l’aspersorio.
Pipìn de l’Oa addormentato sotto un ulivo au Prau e Gialì che va a leccare un fiasco vicino a lui.
Una gallina di Teresa che continua a camminare dopo che con una sassata di piatto le ho staccato completamente la testa.
I primi funghi raccolti nella pineta di Mangiapàn: sensazione di onnipotenza.
Rabbia e rimpianto.
Grillo Nero che mi porta a servire messa a Capo Mele nell’antica cappella detta “La Madonna delle Penne”.
Cesare de Carmelìn che gioca a biglie nella polvere della strada davanti alla scuola; si gioca al “Triangolo”, al “Papa”, Pormu e stecca”, con le terrole, le marmuine, le vedrole e le cristalline”.
Giumìn, ferito negli ultimi giorni di guerra per difendere il ponte sul Merula che i tedeschi avevano minato e volevano far saltare. I buchi neri e sanguinanti nei polpacci e la bacinella con acqua e sale sul tavolo in cucina.
Adriano ed io che portiamo Gialì a far coprire dal becco a Stellanello. A piedi andata e ritorno: uno spasso.
Culetìn che, con una gamba rotta per una caduta, viene adagiata su una scala in legno con un cuscino sotto la gamba e portata a casa da Angiulìn e Nanìn de Mìlia.
Due (o tre?) anziane Signore villeggianti che mi insegnano a suonare il piano in un alloggio di Cae Suttae.
Adriano ed io seduti sul terrazzo del Muettu mentre i grandi lavoravano nel frantoio sottostante. C’è una grande luna piena.
Battistìn u bancaò che mi tira una boccia perché gli dico che sono quadrate e lui non è capace di farle rotonde.
Pinuccia e Anna che spargono i sacchi di fiori di ginestra lungo il percorso della processione del Corpus Domini dalla chiesa a Bande de Là, a Ca’ Bernei, a Cae Suttae.
Adriano che dice a Giuanìn da Culetta: “Se ti ci metti il latte di fico acerbo ti diventa più grosso”. Infatti!
L’altissimo letto di Gigettu dove ho dormito la notte durante la quale è nata Jose perché Pinuccia faceva la levatrice.
Battistìn de Fiuìna che mi tiene la scala mentre vado a prendere i nidi di passero nel sottotetto della sacrestia, passando da un foro della parete Ovest. Sensazioni di caldo e polvere.
“Te rogamus audi nos” Grillo nero con le pie donne che va negli uliveti per le rogazioni nei periodi di siccità ed io che porto l’aspersorio.
Pipìn de l’Oa addormentato sotto un ulivo au Prau e Gialì che va a leccare un fiasco vicino a lui.
Una gallina di Teresa che continua a camminare dopo che con una sassata di piatto le ho staccato completamente la testa.
I primi funghi raccolti nella pineta di Mangiapàn: sensazione di onnipotenza.
Nel corso degli anni, dall’inizio della guerra sino al quarantacinque, avevo accumulato tra i ruderi di Bande de Là, Ca’ Bernei e Ca’ Survòne una vera e propria polveriera con una quantità e varietà di esplosivi tale da demolire tranquillamente due paesi come Rollo.
Avevo iniziato con le cartucce di 91 e di moschetto inesplose e perse dai militari nel poligono di “Mangiapàn”, poi Fernando, nipote del Ca’ d’Ineia, mi aveva portato a piedi sopra Moglio di Alassio dove c’erano le postazioni di cannoni antisbarco da 140 millimetri ed enormi depositi di bossoli con già dentro il sacchettto di balestite giallastra simile a larghe tagliatelle e grosse piramidi di proiettili senza spoletta.
Ritornammo carichi di sacchi di balestite.
Scopersi poi che alla Chiappa c’era una postazione identica ed allora mi abbonai a quella, che era più vicina, andando a rubare sacchi di balestite in quel deposito a volte solo, a volte con Bruno, a volte con Gazzini, detto Napoleone, che abitava ad Andora.
Una notte silurarono una nave di fronte a Cervo e due dei siluri finirono contro la scogliera esattamente dove oggi sorge lo stabilimento “Il Porteghetto”.
Uno esplose, aprendo quello squarcio che ancora si nota nella roccia, l’altro si aperse nell’urto senza esplodere e lasciando sugli scogli enormi pezzi di tritolo che Adriano ed io ci precipitammo a recuperare passando lungo la ferrovia e tingendoci completamente di giallo.
Il tritolo senza detonante non esplodeva ma bruciava come legna con un denso fumo nerastro e nauseabondo, così lo usavamo in spiaggia costruendo vulcani dalla cui sommità usciva fumo.
Venne poi l’otto settembre quarantatrè con recupero di proiettili vari, bengala ed altri razzi, bombe a mano e persino la culatta di un mortaio che faticai come una bestia per portarmi a Rollo.
Inoltre, dopo l’episodio delle mine sotto il letto, ero riuscito a racimolare ancora qualche cassa dal Ponte Romano prima che i tedeschi sgomberassero.
Riuscimmo poi a rubare ai palombari che lavoravano alla nave delle arance per recuperare i motori d’aereo, una cassa di uno strano esplosivo costituito da balestite in cilindri forati come grossa pasta che bruciavano sott’acqua e che accesi da una parte e messi sul pavimento, come feci io a scuola sotto il banco di Maresa Pallavicino, schizzavano da una parte e dall’altra ed erano detti perciò “scurisèrve”*.
Ma il boom venne quando una squadriglia di aerei inglesi, di quelli con la doppia fusoliera, dopo aver abbattuto un aereo tedesco molto lento chiamato “cicogna” scese a mitragliare una colonna di camion militari sull’Aurelia a capo Rollo sopra l’attuale condominio Unità Vacanze.
Avevo iniziato con le cartucce di 91 e di moschetto inesplose e perse dai militari nel poligono di “Mangiapàn”, poi Fernando, nipote del Ca’ d’Ineia, mi aveva portato a piedi sopra Moglio di Alassio dove c’erano le postazioni di cannoni antisbarco da 140 millimetri ed enormi depositi di bossoli con già dentro il sacchettto di balestite giallastra simile a larghe tagliatelle e grosse piramidi di proiettili senza spoletta.
Ritornammo carichi di sacchi di balestite.
Scopersi poi che alla Chiappa c’era una postazione identica ed allora mi abbonai a quella, che era più vicina, andando a rubare sacchi di balestite in quel deposito a volte solo, a volte con Bruno, a volte con Gazzini, detto Napoleone, che abitava ad Andora.
Una notte silurarono una nave di fronte a Cervo e due dei siluri finirono contro la scogliera esattamente dove oggi sorge lo stabilimento “Il Porteghetto”.
Uno esplose, aprendo quello squarcio che ancora si nota nella roccia, l’altro si aperse nell’urto senza esplodere e lasciando sugli scogli enormi pezzi di tritolo che Adriano ed io ci precipitammo a recuperare passando lungo la ferrovia e tingendoci completamente di giallo.
Il tritolo senza detonante non esplodeva ma bruciava come legna con un denso fumo nerastro e nauseabondo, così lo usavamo in spiaggia costruendo vulcani dalla cui sommità usciva fumo.
Venne poi l’otto settembre quarantatrè con recupero di proiettili vari, bengala ed altri razzi, bombe a mano e persino la culatta di un mortaio che faticai come una bestia per portarmi a Rollo.
Inoltre, dopo l’episodio delle mine sotto il letto, ero riuscito a racimolare ancora qualche cassa dal Ponte Romano prima che i tedeschi sgomberassero.
Riuscimmo poi a rubare ai palombari che lavoravano alla nave delle arance per recuperare i motori d’aereo, una cassa di uno strano esplosivo costituito da balestite in cilindri forati come grossa pasta che bruciavano sott’acqua e che accesi da una parte e messi sul pavimento, come feci io a scuola sotto il banco di Maresa Pallavicino, schizzavano da una parte e dall’altra ed erano detti perciò “scurisèrve”*.
Ma il boom venne quando una squadriglia di aerei inglesi, di quelli con la doppia fusoliera, dopo aver abbattuto un aereo tedesco molto lento chiamato “cicogna” scese a mitragliare una colonna di camion militari sull’Aurelia a capo Rollo sopra l’attuale condominio Unità Vacanze.
Uno dei camion precipitò nella scarpata finendo sulla sottostante linea ferroviaria e disseminando il percorso di proiettili da mitragliera da 22 millimetri, di altri proiettili da cannoncino grandi il doppio, di casse scardinate di bombe a mano di quelle col manico e di altre fatte ad uovo col cappelletto azzurro.
Mi feci aiutare da Bruno di Melotto, figlio di Teresa a trasportare a Rollo tanto prezioso materiale.
Credo che lassù Qualcuno, con la coda dell’occhio mi abbia seguito per tutti quegli anni perchè, tanto per citare un sistema, scaricavo i vari tipi di proiettili svitando la spoletta con le tenaglie per recuperare l’esplosivo interno, di colore rosa e con uno strano odore pungente, e quando non riuscivo perché la spoletta era ossidata davo alcuni colpi col proiettile contro un sasso per sbloccarla …
Nel quarantacinque tutto rimase dove lo avevo nascosto ma quando, dopo quasi mezzo secolo, ritornai in quei ruderi per effettuare dei rilievi la mia polveriera non esisteva più.
Mi feci aiutare da Bruno di Melotto, figlio di Teresa a trasportare a Rollo tanto prezioso materiale.
Credo che lassù Qualcuno, con la coda dell’occhio mi abbia seguito per tutti quegli anni perchè, tanto per citare un sistema, scaricavo i vari tipi di proiettili svitando la spoletta con le tenaglie per recuperare l’esplosivo interno, di colore rosa e con uno strano odore pungente, e quando non riuscivo perché la spoletta era ossidata davo alcuni colpi col proiettile contro un sasso per sbloccarla …
Nel quarantacinque tutto rimase dove lo avevo nascosto ma quando, dopo quasi mezzo secolo, ritornai in quei ruderi per effettuare dei rilievi la mia polveriera non esisteva più.
A settembre del millenovecentoquarantacinque Pinuccia mi portò ad Alassio ed andammo ad abitare in un appartamento, con l’acqua che in casa usciva dai rubinetti senza andare a prenderla nel pozzo; inoltre se ne andava via da sola; c’era anche la luce elettrica che non faceva male agli occhi e bastava girare un interruttore di ceramica per accenderla senza fiammifero; il gas che serviva per cucinare senza legna e un cesso che si portava via tutto con l’acqua di una scatola che scendeva in un tubo.
Iniziai a frequentare la scuola media dai Salesiani, a fare nuove amicizie con i ragazzi del quartiere, a leggere qualche giornale e la mia vita lentamente cambiò, ma la notte, nel mio letto col materasso di lana, mi oppresse per anni una infinita struggente nostalgia per un mondo che avevo perduto.
Per sempre.
Iniziai a frequentare la scuola media dai Salesiani, a fare nuove amicizie con i ragazzi del quartiere, a leggere qualche giornale e la mia vita lentamente cambiò, ma la notte, nel mio letto col materasso di lana, mi oppresse per anni una infinita struggente nostalgia per un mondo che avevo perduto.
Per sempre.
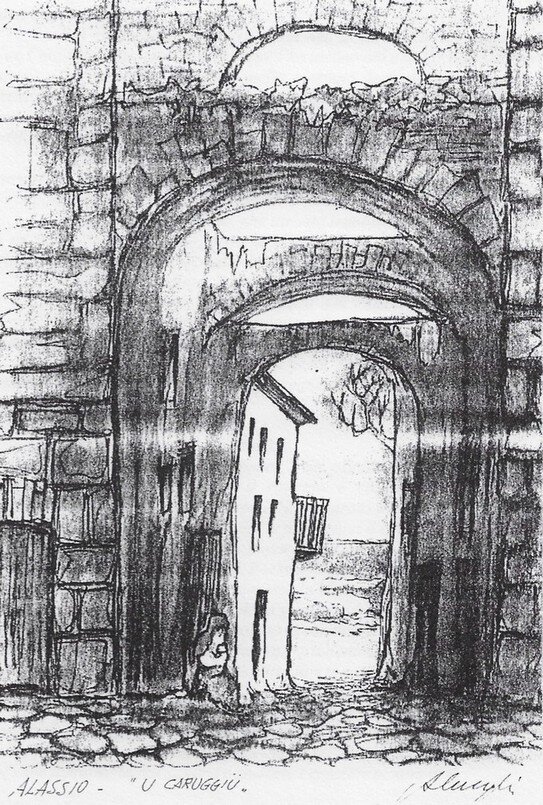
y
TEMPI DA LUVI
di Luciano Dabroi
Quando incontri un uomo, prima di giudicarlo guardalo da diversi punti
di vista
Ho conosciuto Luciano Dabroi nell’arido ufficio del segretariato d’un
Consorzio detestato e combattuto. L’ho incontrato a Rollo, nella sua terra,
intento a preparare il “cundiun” nella giornata degli aromi. Sono entrata
abusivamente nel segreto della sua vita, leggendo i ricordi dell’infanzia,
negli anni 30 e 40. Anni travolti dal tempo. Un tempo che scorrendo veloce, li
ha trasformati e resi irriconoscibili.
“Possibile?”. Possibilissimo, perché ce lo descrive Luciano Dabroi, con
un brio, una naturalezza, una freschezza meravigliosa.
Non è lo scrittore che elabora il pensiero e lo trasforma.
E’ l’incanto dell’uomo, che tornato bambino, rivive la sua infanzia in
un villaggio poverissimo, dove la vita non era facile, ma conservava il profumo
della genuinità e la poesia del primordiale.
L’ho letto d’un fiato. Ed ho conosciuto il vero Luciano Dabroi.
A due, tre anni la sua fantasia già riusciva a trasformare un
fazzoletto infilzato su una canna, e agitato nel vento, non in una bandiera che
lui non conosceva, ma nel volo d’un uccello e di fantastiche farfalle.
Peccato che la mamma non fosse d’accordo a veder lacerati i fazzoletti
che lei conservava, anche rammendati, nel comò, insieme alla lavanda.
E, ogni volta, erano botte.
E quante botte prese dal papà.
Ci si chiede: “Faceva bene?” Gli psicologi di oggi, certamente,
risponderebbero di no. Eppure il ragazzo è cresciuto, ha imparato a
sopravvivere in mezzo a mille pericoli. Ha imparato a camminare scalzo tra i
rovi, a disinfettare le ferite con la pipì, a procurarsi il cibo, quando lo
stomaco vuoto reclamava la sua parte. Ha imparato ad amare e rispettare i
genitori nonostante tutte le botte e i castighi. Forse il ragazzo irrequieto e
selvaggio, ma che si alzava alle cinque per servire la Messa a Grillo Nero e
passava le notti a leggere, consumando l’olio della giara, e rubava il pane ai
canarini non sarebbe oggi il ricercatore appassionato di conchiglie e minerali.
Non avrebbe alle sue spalle un patrimonio che, opportunamente valorizzato,
potrebbe costituire la ricchezza culturale della cittadina in cui vive.
Bravo Dabroi.
“Tempi da luvi” è un manoscritto che deve essere stampato e divulgato.
I ragazzi ai quali, oggi, non manca nulla, devono sapere che si può vivere
anche in un altro modo e che i “testaiui” del papà e della mamma, non solo non
fanno male, ma aiutano a crescere e crescere uomini veri.
Angela Biedermann
y
y
L’AUTORE
Nato ad Andora in Frazione Rollo, anzi Borgata Ca’
Bernèi, il ventotto febbraio 1933, si è diplomato in agraria all’ Istituto C.
Gallini di Voghera e laureato in Economia e Commercio all’ Università di
Genova.
Ha lavorato alcuni anni
in Argentina come amministratore di una azienda agricola.
Ritornato in Italia si è
dedicato all’ insegnamento ed ha aperto uno studio di amministrazione di
stabili.
Pensionato, ha ripreso a
lavorare all’estero in Tunisia come consulente e collegamento tra i progettisti
tunisini di un grande complesso ad Hammamet ed i tecnici francesi progettisti
del porto annesso al complesso.
Negli ultimi anni ha
svolto lavori di prospezione in Costa d’Avorio, nelle concessioni forestali
governative ad imprese italiane per il taglio e l’esportazione di legname
pregiato.
Collezionista di
minerali e conchiglie ha l’aspirazione di donare le sue collezioni al Comune di
Andora perché, in sede adatta, sia costituito un museo di scienze naturali.
y