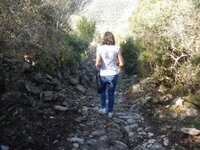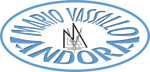FRAZIONE SAN PIETRO
TESTIMONIANZE DAL PASSATO > BORGATE E FRAZIONI > LE BORGATE
SAN PIETRO
(Sabrina Lunghi)

Estratto mappa impianto Nuovo Catasto Terreni - Agenzia delle Entrate
y
Riguardo a questa parrocchia, si è conservato un documento utile ad attestarne l’antichità, nel quale oltre alla ecclesia S. Petri, sono citate altre borgate inserite nel suo comprensorio, che possono quindi considerarsi già esistenti e sviluppate alla fine del ‘400. Tale documento è infatti un testamento che reca la data del 28 Agosto 1498. In esso Christofarus Galiana q(uondam) Iacobi de Andoria legat sepeliri in cemeterio ecc(lesiae) S. Petri Vallis And(o)r(ia) ubi sepulti sunt antecessores sui et illi de Albergo suo. Legat consortie Virginis Marie glosum unum. Leg(at) in reparatione blandoni S(anc)ti Petri sol(di) 5. Leg(at) domui Verberator(um) S(anc)ti Luca pro eius reparat(ione) possesionem un(am) in vale And(oriae) loco ubi d(icto) metam sive locam et aliam, cum co(n)su(etu)d(i)ne quod per homines inf(rascrip)tos quos eleg(unt) patronos accjpiebant libre centum que hab(e)ant reddere o(mn)i tempore ad blandonum seu cereum d(ict)i testatoris que extat ante altare Beate Virginis Marie in ecc(lesi)a S(anc)ti Petri, et de cuius redditib(us) debeant manutenere (...) cereum et blandonum et in sec(ul)a seculor(um). Et quando celebrabitur missa ad altare debat accendi et o(mn)i die festive.
Iti 1eg(at) dicte domui verberat(o)rum aliam terram ubi dic(tam) campo longo ut om(n)i die Dom(ini)co quando habebunt finitum eor(u)m off(ciu)m debeant habere Presbiterum unum qui celebret unam missam pro anima ipsius et quod Prior (...) debat dicere 5 pater noster et 5 ave maria pro an(ima) ipsius et sic fa(c)ere debant dicere ab omn(i)b(us) confratribus et disciplinantib(us) et hoc semp(e)r in secula seculorum. It(em) alii cerei ante crocifìxum quando dicunt officium (…) si aliq(uis) Episcopus Vicarius (...) vellet hoc prohibere teneantur nubere pauperas fìlias, quod homines de Gallianis debant e(sser)e patroni et ei dejficeret, sint patroni duo procu(rato)res domui S(anc)ti Luca.
Act(us) Andorie in villa plani rubei in domo hered(um) q(uondam) oberti travie, presentibus Christofarus Travia q. L(aurentii), Jo(hanes) Rebecho, Luca Paulo Richelmo q(uondam) Ant(onius), Nicolao Micherio q(uondam) Jo(hanes), Bart(olomeus) Rebecho q(uondan7) Pelegri de Andor(ia).
Lazarinus Trevia Not(arius). De Arch(ivio) Cath(edralis) sumptu [119].
Di tale testamento parla diffusamente anche il Giardinello [120].
Integrando le due testimonianze, si deduce che alla fine del ‘400 la Chiesa di S. Pietro già esisteva, ed era evidentemente importante in quanto destinataria di una cospicua somma di denaro (100 lire), vicino alla quale era presente il cimitero, nel quale erano già seppelliti gli antecessores di colui che fece il testamento, la cui esistenza si sarà svolta quindi fra ‘300 e ‘400.
E’ anche citato l’oratorio di S. Luca, sede di una confraternita di Disciplinanti, le cui funzioni si svolgevano ogni domenica e durante ogni festività.
Chi dettò questo testamento lasciò una clausola curiosa; si dice infatti che, qualora il vescovo o un suo vicario si fossero opposti ai lasciti in favore dell’oratorio, tale denaro si sarebbe dovuto destinare a fanciulle indigenti. Una consuetudine questa che si ritrova anche a Conna, circa centocinquanta anni dopo, in due legata del 1629 e del 1631, nei quali il reverendo Pietro Maria Guardone e suo fratello lasciarono circa settecento scudi in maritando et dotando puellas e pro pauperibus [121].
Sede dell’atto del 1498 fu una casa situata in villa plani rubei cioè in Pian Rosso, località quindi già costituita in quella data. Così, fra i testimoni era presente un Nicolao Micherio, proveniente certamente da Colla Micheri, perché questo cognome era diffuso solo in tale borgata, anch’essa quindi da attestarsi già in quell’anno.
Certamente dunque la chiesa di S. Pietro è molto antica e risale almeno al Basso Medioevo, anche se è difficile individuare una data ante 1498 precisa. Ma si può presumere che almeno un secolo prima di questa data, essa fosse già stata edificata, in una forma ormai scomparsa a seguito di successivi ampliamenti e rifacimenti, che le hanno conferito l’aspetto visibile in Fig. 81, m. 16 x m. 24. Però il campanile, nella parte inferiore conserva probabilmente le dimensioni originali. Infatti la sua mole massiccia dalla base a circa metà altezza, e le aperture ad archetto - ora tamponate - (Fig. 82) possono riferirsi alla prima edificazione, in evidente contrasto con la parte superiore più slanciata ed elegante (Fig. 83), riferibile quindi ai secoli successivi.
Gravitavano intorno al quartiere di S. Pietro le frazioni di Pian Rosso, Metta, Galleani, Negri e Duomo.
y
119 RAIMONDI, Rif. 35, p. 70 e s.
120 GIARDINELLO 1624, cc. 415, 415 retro, 417 e 417 retro.
121 RAIMONDI, Rif. 35, p. 79
Testo tratto dalla Tesi di Laurea “Insediamenti medievali nella Valle del Merula: esame tipologico" di Sabrina Lunghi - Anno Accademico 1995/1996, rel. Prof. C. Varaldo.
y